|
|
|
Progetto per una mostra
Espressionismo siciliano
Sergio Spadaro |
|
|
|
1.
Caratteri dell’Espressionismo storico
|
|
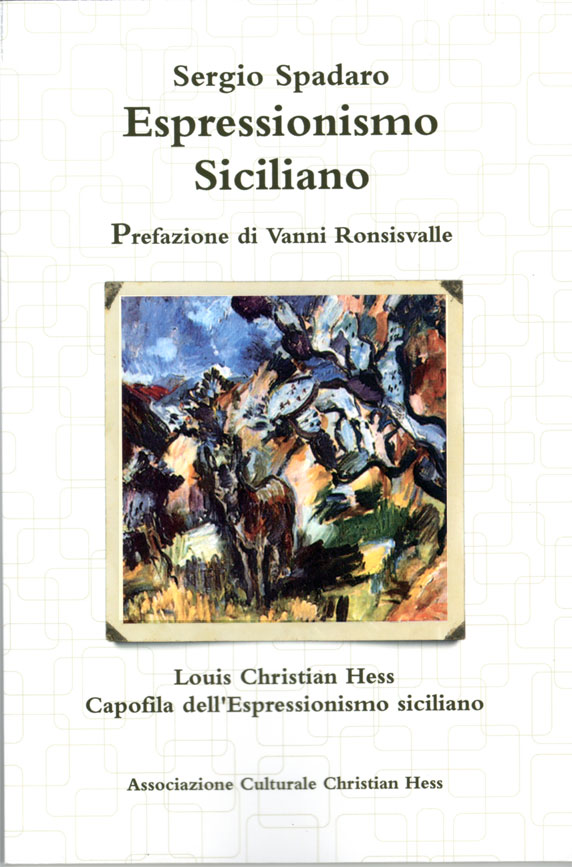 Uno degli antecedenti dell’Espressionismo tedesco degli
inizi del Novecento è da vedere in quella “tendenza
anti-impressionista che si genera in seno
all’Impressionismo stesso come coscienza e superamento
del suo carattere essenzial-mente sensorio e che si
manifesta sul finire dell’Ottocento con Toulouse-Lautrec,
Gauguin, Van Gogh, Munch, Ensor” [G.C.Argan, L’arte
Moderna, Sansoni, FI 1990]. Altre solleci-tazioni e
fonti sono però da vedere nella stessa cultura della
tradizione tedesca, ad esempio “nella grafica e nello
Jugendstil nel complesso. Rimontano alla scoperta
della forza espressiva della scultura primitiva, della
pittura contadina su vetro o della xilografia medievale.
[…] Né è da dubitarsi, infine, che la filosofia e la
letteratura ottocentesche abbiano fatto da madrine
all’avvio verso il nuovo, così come Friedrich Nietzsche
e i pensatori ‘anticlassici’, che anticiparono le
tematiche della volontà e del Wollen, dell’atto
creativo” [Joachim Büchner, Espressionisti dal museo
Sprengel di Hannover, Mazzotta, MI, 1984]. Infine,
“uno dei motivi che confluisce nell’arte e nella cultura
tedesca che hanno dato origine all’Espressionismo è
quello dell’Ur-schrei, il “grido originario”,
cioè quello di una visione interiore della vita nella
quale l’uomo ricerca se stesso e l’autenticità di
un’esistenza veramente libera, come già espresso da
Meister Eckart condannato come eretico nel 1329” [Luigi
Rognoni, Introduzione a Arte tedesca fra
le due guerre di Waldemar Jollos, Mondatori, MI,
1955]. A quest’ultimo riguardo tutti conoscono il
dipinto del norvegese Edward Munch del 1893, intitolato
L’urlo (Skrik), che può “essere indicato
come un vero manifesto dell’allucinazione
espressionista”. Uno degli antecedenti dell’Espressionismo tedesco degli
inizi del Novecento è da vedere in quella “tendenza
anti-impressionista che si genera in seno
all’Impressionismo stesso come coscienza e superamento
del suo carattere essenzial-mente sensorio e che si
manifesta sul finire dell’Ottocento con Toulouse-Lautrec,
Gauguin, Van Gogh, Munch, Ensor” [G.C.Argan, L’arte
Moderna, Sansoni, FI 1990]. Altre solleci-tazioni e
fonti sono però da vedere nella stessa cultura della
tradizione tedesca, ad esempio “nella grafica e nello
Jugendstil nel complesso. Rimontano alla scoperta
della forza espressiva della scultura primitiva, della
pittura contadina su vetro o della xilografia medievale.
[…] Né è da dubitarsi, infine, che la filosofia e la
letteratura ottocentesche abbiano fatto da madrine
all’avvio verso il nuovo, così come Friedrich Nietzsche
e i pensatori ‘anticlassici’, che anticiparono le
tematiche della volontà e del Wollen, dell’atto
creativo” [Joachim Büchner, Espressionisti dal museo
Sprengel di Hannover, Mazzotta, MI, 1984]. Infine,
“uno dei motivi che confluisce nell’arte e nella cultura
tedesca che hanno dato origine all’Espressionismo è
quello dell’Ur-schrei, il “grido originario”,
cioè quello di una visione interiore della vita nella
quale l’uomo ricerca se stesso e l’autenticità di
un’esistenza veramente libera, come già espresso da
Meister Eckart condannato come eretico nel 1329” [Luigi
Rognoni, Introduzione a Arte tedesca fra
le due guerre di Waldemar Jollos, Mondatori, MI,
1955]. A quest’ultimo riguardo tutti conoscono il
dipinto del norvegese Edward Munch del 1893, intitolato
L’urlo (Skrik), che può “essere indicato
come un vero manifesto dell’allucinazione
espressionista”.
“Letteralmente espressione è il contrario di
impressione. L’impressione è un moto dall’esterno
all’interno: è la realtà (oggetto) che s’imprime nella
coscienza (soggetto). L’espressione è un moto inverso,
dall’interno all’esterno: è il soggetto che imprime di
sé l’oggetto. […] La deformazione espressionista non è
la caricatura della realtà: è la bellezza che,
passando dalla dimensione dell’ ideale a quella del
reale, inverte il proprio significato, diventa
bruttezza ma sempre conservando il suo segno di
elezione. […] Il brutto non è altro che un
bello caduto e degradato. […] Soltanto l’arte, come
lavoro puramente creativo, potrà compiere il miracolo:
riconvertire in bello quello che la società ha
pervertito in brutto. Da qui il tema etico fondamentale
della poetica espressionista: l’arte non è soltanto
dissenso rispetto all’ordine sociale costituito, ma
volontà e impegno di mutarlo. E’ quindi un dovere
sociale, un servizio a cui si adempie” [G. C. Argan,
L’arte moderna, citato].
Due sono i gruppi pittorici che stanno all’origine
dell’Espressionismo: uno figurativo e l’altro che
porterà all’astrazione non geometrica. Il primo, Die
Brücke (Il ponte), sorse a Dresda fin dal
1903 su iniziativa di Ludwig Kirckner, Fritz Bleyl, Karl
Schmidt-Rottluff ed Erich Heckel; ai quali si uniranno
nel 1906 Emil Nolde, Max Pecstein e, nel 1908 e nel
1910, Kees Van Dongen e Otto Müller. Il gruppo da Dresda
si spostò a Berlino nel 1911, ma si sciolse
definitivamente nel 1913. Nella Brücke “due sono
i temi dominanti: la figura umana e l’ambiente che la
circonda, paesaggio e natura, città e architettura
urbana” [Joachim Büchner, Espressionisti dal museo
Sprengel di Hannover, citato]. Sotto un aspetto più
propriamente pittorico, “negli artisti della Brücke
c’è un progressivo rifiuto della spazialità in nome
della strutturazione bidimensionale, nel valore timbrico
del colore piatto, nel linearismo grafico” [Lara-Vinca
Masini, L’arte del Novecento, Editoriale
L’Espresso, RM, 2003].
Il secondo gruppo, Der Blaue Reiter (Il
cavaliere azzurro), nacque a Monaco nel 1911, con
Wasilj Kandinskij, Gabriele Münter, Franz Marc; ad esso
aderirono Alexej von Jawlensky, August Macke ed Heinrich
Campendorck, Alfred Kubin, Paul Klee e, nel 1913, Lyonel
Feininger.
Pur non appartenendo ad alcun gruppo, non si possono non
citare gli austriaci Egon Schiele e Oscar Kokoshka, che
“spingono alle estreme conseguenze l’interiorità
romantica, portandola alla decomposizione della forma
sino a riassumere il barocco come accesa scrittura
psicologica” [Luigi Rognoni, Introduzione,
citato]. Nel 1912 escono il famoso fascicolo Der
BlaueReiter, curato da Kandisnskij e Marc, e del
primo uno dei più importanti documenti dell’arte moderna
e dell’Espressionismo in particolare, Della
spiritualità nell’arte (Uber des Geistige in derKunst).
Mentre la pittura della Brücke “assume il
carattere di una acutizzazione psicologica dell’oggetto
che l’artista filtra nella propria esperienza, con
libertà istintiva, […] quella del Blaue Reiter
parte invece da una rivolta totale, ponendo l’accento
sull’immediatezza spirituale della vita interiore, come
grido di liberazione dal terreno e dal fisico sino a
giungere poi con Kandisnskij all’armonia di un nuovo
ordine spirituale nella forma astratta” [Luigi Rognoni,
Ibidem].
In estrema sintesi e guardando ai movimenti artistici
cui daranno vita, “si identificano così due filoni
dell’Espressionismo: il primo, scaturito dalla Brücke
(e con varie componenti: dal Futurismo al post cubismo
picassiano fino al Dadaismo, al Surrealismo e anche alla
Metafisica), porterà alla Nuova Oggettività (Neue
Sachlichkeit) degli anni Venti e Trenta,
all’espressionismo realista messicano postrivoluzionario
(Rivera e Siqueiros) e al Realismo sociale europeo del
secondo dopoguerra. Il secondo filone, che si origina
dal Blaue Reiter, darà il via a tutte le
esperienze non figurative, sia nella forma
astratto-concreta e geometrica, che si originerà dal
concretismo di Malevič e degli stessi strutturalisti e
formalisti russi e dal Neo-plasticismo degli olandesi
Mondrian e van Doesburg (anche se filtrato dal Cubismo),
sia nelle forme che si svilupperanno nell’Espressionismo
astratto americano e nell’Informale europeo del secondo
dopoguerra” [Lara-Vinca Masini, L’arte del Novecento,
citato].
Per quanto riguarda la Neue Sachlichkeit, va
precisato infine che essa “abbandona l’individualismo
espressionista e assume, nei letterati e nei pittori,
una posizione critica di fronte alla società tedesca.
L’osservazione è portata al realismo crudele che si
acutizza fino all’allucinazione ‘fiamminga’ di un Otto
Dix e al violento atto d’accusa contro la borghesia e il
militarismo nell’atroce disegno di un George Grosz.
Maggiormente legato all’esperienza espressionista, Max
Beckmann volge a un realismo che sembra riallacciarsi
alla pittura tedesca del sec. XV, e appare a Waldemar
Jollos “capace di condurre dalla smorfia al simbolo”
[Luigi Rognoni, Introduzione, citato].
|
|
2.
Louis Christian Hess
espressionista in Sicilia |
|
LOUIS CHRISTIAN HESS (Bolzano 1895 –
Schwaz 1944) è da
considerare come il precursore – almeno in senso ideale
– dell’Espressionismo siciliano, anche se le sue opere
hanno cominciato ad essere conosciute ed apprezzate solo
a partire dal 1974, cioè dalla prima retrospettiva
tenuta a Palermo. Formatosi a Innsbruck e a Monaco, dove
frequenterà l’Accademia, compie nel 1925 il primo
viaggio in Sicilia, dove vive la sorella Emma sposata
con un commerciante di Messina. Da allora la Sicilia
sarà la sua meta abituale e, come dice Carl Kraus nel
catalogo per la mostra di Schwaz e Bolzano del 2008-09 (Ed.
Athesia, BZ), costituirà una svolta anche per la
sua pittura: “Bastano le prime impressioni ad aprire al
pittore un mondo del tutto nuovo, fatto di gente immersa
nelle proprie antiche tradizioni, di un paesaggio in cui
pulsano i miti classici, della incomparabile luce
mediterranea. Hess scrive agli amici rimasti in Germania
di aver trovato il paradiso […]”.
Proprio per la diversità di ispirazione e di esiti che
l’opera di Hess presenta, converrà tenere distinte le
due fasi. In quella presiciliana, quasi tutta la critica
concorda che Hess manifesta affinità e contatti
soprattutto con la pittura di Karl Hofer e di Max
Beckmann. Per il primo, è da tenere presente che anche
Hess fece parte dei pittori cosiddetti Jurifreie (i
Fuorigiuria), che si erano affiancati a quelli del
Novembergruppe, operanti fin dal 1918. In Arte
tedesca fra le due guerre [citato], un testimone
come Waldemar Jollos recensisce le loro mostre del 1924,
del 1925 e 1929, che si erano tenute tutte al Lehrter
Bahnhof di Berlino. E poiché Hofer – di cui Jollos
apprezza “i tentativi di giungere a una nuova
architettura del disegno” – partecipava a queste mostre,
è evidente che i contatti con Hess erano avvenuti per
tale tramite. Comunque, poi Hofer farà una mostra di
quadri astratti nel 1933 (alla Galleria Flechtheim di
Berlino) e con ogni probabilità anche l’influsso se non
vero e proprio “astratto”, di gusto astrattizzante, di
certi quadri di Hess è probabile che derivi da lui (ved.
Case rosso-nero del 1933 o Composizione
del 1937).
Ma è con Beckmann che la pittura di Hess mostra maggiori
affinità. Già Carl Kraus, nel catalogo succitato,
riproduce l’Autoritratto con sassofono di
Beckmann del 1930 e si può vedere subito l’affinità
tematica con Prova al concerto n° 2 di Hess, del
1928/1930, dove ci sono due suonatori di fagotto, uno
stante e uno seduto dietro a un leggio. Il cromatismo
nero e angoscioso di Beckmann è poi richiamato ne Il
giocatore di scacchi del 1931. Anche se sarà l’oggettualismo
della realtà, discendente dalla Neue Sachlichkeit
di Beckmann, a influenzare maggiormente Hess. Come dice
Flavio Caroli, in occasione della grande retrospettiva
di Beckmann tenutasi alla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma del 1996, “ricchezza del visibile, cioé
dell’infinità dei fenomeni, e ricchezza del mistero che
li anima, come d’altronde scrive, con qualche brutalità,
l’artista stesso: ‘Si tratta sempre di cogliere la magia
della realtà e di tradurre questa realtà nella pittura.
Rendere visibile l’invisibile attraverso la realtà.
Forse questo può suonare come un paradosso, ma è proprio
la realtà che costituisce il vero mistero
dell’esistenza’ “ [Ricchezza del visibile, “Il
Sole/24 Ore” del 25.2.1996].
Prima di passare alla fase siciliana della pittura di
Hess, non si può non notare come la tematica dei suoi
quadri, in Germania, resti tipicamente vincolata a
un’ispirazione cittadina, rappresentata dagli “interni”
della gran quantità di opere con le “modelle” (Baronessa
con veletta, Donna con cappello nero, Donna allo
specchio del 1930; Dalla modista, Tre modelle,
Due modelle, Modella nell’atelier con pelliccia di volpe,
del 1932).
A quale “ricchezza” perverrà Christian Hess in Sicilia
è facile constatare dalla visione delle sue opere.
Innanzitutto, la solarità della luce mediterranea
schiarirà anche la sua tavolozza. Abbandonati gli
“interni” borghesi, passerà subito a un diretto contatto
con la natura e con le persone della quotidianità
lavorativa (contadini, pescatori, muratori, ecc.). A
cominciare, fin dalla sua prima venuta a Messina, con
quell’Asinello e fichidindia (1925) che può
essere assunto a emblema della sicilianità dei suoi
tempi: già, perché ai tempi di Hess uno dei mezzi di
trasporto consueti era ancora l’asinello (ved.
l’acquarello del 1930 Donne sull’asino). Il
paesaggio dello Stretto sarà poi trasposto in vari modi
(Veliero e case del 1931, Veliero sullo
Stretto del 1933, Piccioni sulla terrazza del
1933, Agave, Kleine Terrasse e Antonia e
veliero del 1934, Paesaggio con binari e bandiera
del 1935). Non si contano le opere dedicate alle
“barche”, ai “pescatori”, ai “bagnanti”. Persino le
nature morte, attraverso l’emblematicità caratterizzante
degli oggetti rappresentati, alluderanno alla natura
siciliana: Balcone in Sicilia del 1928 (con due
peperoni e piante grasse tipiche siciliane), Aguglie
sulla fruttiera del 1933 (ma i pesci tipici dello
Stretto sono poi raffigurati in uno splendido acquarello
e in un disegno), Natura morta con la Gazzetta
(dove ci sono due melanzane bianche tipiche del clima
locale) del 1933, Natura morta con quartara (con
i peperoni contorti) del 1933, o in quelle due nature
morte di gusto quasi cubistico del 1935 (con Fiasco e
pere e con Asso di fiori). Anche i personaggi
popolari del tempo saranno raffigurati, come
L’indovino del 1933 e Ladro e Carabiniere del
1934: e persino, a prova dei contatti e della comunanza
che egli aveva con la gente del luogo, nell’Autoritratto
come pescatore del 1933 (Hess si raffigura in primo
piano, nell’atto della “voga”, come si usava nello
Stretto).
Durante i soggiorni e la permanenza in Sicilia, Hess
ebbe anche modo di recarsi a Palermo, a Monreale,
all’Aspra, a Siracusa e Agrigento, perché ricercava
sempre – come peraltro ha fatto a Firenze o Napoli – le
“fonti” classiche. E ciò viene rispecchiato nella sua
pittura, come si può vedere in Torso giacente del
1928, Figure mitologiche del 1930 o persino
nell’inchiostro del 1938 dove una modella è ripresa come
Mùtila. In tale ottica di riscoperta della
classicità vanno anche visti certi dipinti con gli
antichi monumenti di Messina (Nettuno del 1927,
con la statua del Montorsoli abbinata alle ciminiere e
ai boccaporti dei rimorchiatori, e Donne di Messina
del 1933, dove il monumento a Don Giovanni d’Austria
fronteggia la normanna, ma rimaneggiata nel 1200, Chiesa
dei Catalani).
Che tra gli ideali di Hess non ci fosse soltanto
l’individualità romantica espressionista, ma lo stesso
umanesimo classico di Goethe, lo si può dedurre da un
richiamo che egli fa nell’opera Il riposo dei
muratori del 1929: qui la figura in secondo piano
poggia il braccio su un cippo e si regge con la mano la
testa pensosamente. E’ un espresso richiamo alla posa
nella quale fu ritratto Goethe da J. H. Tischbein nel
1787. D’altra parte Hermann Bahr, tra i primi teorici
del movimento espressionista, si riferisce a Nietzsche (Nascita
della tragedia, 1871) ma anche a Goethe:”L’uomo è
andato oltre Nietzsche, o meglio, è tornato a Goethe; ma
non si accontenta più che l’arte ‘abbellisca’ la vita o
‘nasconda’ o trasfiguri il ‘brutto’, vuole che porti
essa stessa la vita, la crei da sé, come l’atto
primigenio dell’uomo. La pittura, dice Goethe,
rappresenta quello che l’uomo potrebbe e dovrebbe
vedere, non quello che l’uomo comunemente vede” [H.Bahr,
Expressionismus, Monaco, 1916].
Louis Christian Hess, che ha avuto un’esistenza tragica
e travagliata, tra difficoltà economiche e il clima
dittatoriale politico che lo spinse tante volte e
espatriare (anche le sue opere furono bruciate nei roghi
nazisti dell’entartete Kunst), e che purtroppo
finì la sua breve vita in conseguenza dei bombardamenti
angloamericani su Innsbruck, riuscì malgrado tutto a
portare a compimento i suoi ideali artistici in maniera
personalissima e originale, al punto che si può
affermare che egli, al contrario di tanti altri suoi
sodali della pittura, trovò “la conclusione dialettica e
conclusiva della contraddizione storica di classico e
romantico, intesi come ‘costanti’, rispettivamente, di
una cultura latino-mediterranea e di una cultura
germanico-nordica” [G.C.Argan, L’arte moderna,
citato].
|
|
3.
La triade postbellica del realismo sociale |
|
Ci sembra giusto prendere le mosse da quella triade di
pittori che, a partire almeno dalla fine della seconda
guerra mondiale, era indicata come maggiormente
rappresentativa di quella tendenza della arte italiana
denominata “realismo sociale”: Renato Guttuso, Giuseppe
Migneco e Saro Mirabella. Pittori che, in sede politica,
erano compagnons de route del più grande partito
organizzato del movimento operaio, il P.C.I. (Guttuso
addirittura fece parte dei suoi organi direttivi e
affiancò sempre, in sede critico-teorica, la stampa di
tale partito). Peraltro, come fa Luciano Caramel, è
opportuno ricordare pure che Roman Jakobson, già nel
1921, metteva in guardia sull’ambiguità e non
definitorietà del termine “realismo”, perché “teorici e
critici dell’arte non giungono a distinguere i vari
concetti che si celano sotto quell’etichetta, li
trattano come un sacco che si possa allargare a
dismisura per fargli contenere qualunque cosa” [Prefazione
a Renato Guttuso, opere Fondazione
Francesco Pellin,
Mazzotta, MI, 2005].
RENATO GUTTUSO
(Bagheria [PA] 1912 –
Roma 1987), che di quella triade fu la punta di
diamante,firmò già i primi dipinti nel 1924, dodicenne.
Agli inizi seguì in parte il pittore futurista sui
generis Pippo Rizzo e la sintesi “novecentesca”, ma
ebbe anche modo di guardare ai pittori di carretti del
suo paese natale e fu forse grazie a tale formazione che
l’elemento “popolare” nella sua arte rimase sempre
presente. A metà degli anni Trenta peraltro – come
afferma Enrico Crispolti, che dell’opera di Guttuso si
può considerare il massimo conoscitore e il più
esauriente descrittore – “già costituisce il ceppo
originario e fondamentale della propria poetica: la
poetica realista o poetica della naturalezza [in
R.Guttuso, opere Fondazione Francesco Pellin, Ibidem].
Crispolti, che ha curato un Catalogo generale dei
dipinti guttusiani in quattro volumi [Mondatori, MI,
1983-1989], suddivide l’opera del pittore in cinque
periodi (“formazione”fra gli anni Venti e Trenta,
“realismo espressionista”nei primi anni Quaranta,
“postcubismo narrativo” nei secondi anni Quaranta,
“realismo esistenziale e della memoria” negli anni
Cinquanta e Sessanta, “realismo allegorico” negli anni
Settanta e Ottanta). Poiché in questa sede non si
può ripercorrere il percorso guttusiano in maniera
dettagliata, ci limitiamo a qualche precisazione.
Guttuso conoscerà Picasso nel 1946 (a Parigi) e da
allora ne nascerà un’amicizia che durerà tutta la vita.
Il suo “postcubismo” guarda alle “novità della pittura
picassiana da Guernica (1937) in poi e dispiega a
una dimensione quasi epica un racconto di immagini
tipiche del lavoro contadino e operaio”(Fuga
dall’Etna, 1939; Ragazze di Palermo, 1940;
Crocifissione, 1940/41) [E.Crispolti, Ibidem].
Non perciò il cubismo “sintetico” degli anni Dieci e
Venti, o quello braqueiano, più formalistico. Il suo
realismo diventa poi “esistenziale” e “memoriale”, sia
per la forte caratterizzazione di polemica sociale
(ciclo di Scilla, 1949/50; Portella della Ginestra,
1953), sia per l’attenzione a una realtà sociale
emergente in tempi di massa (Boogie-woogie, 1953;
La spiaggia, 1955/56) e infine perché, col ciclo
dell’Autobiografia (1966) entra in gioco una
componente nuova, la memoria. L’attenzione memoriale e
introspettiva, infine, declinerà in composizioni che
riassumono allegoricamente la condizione individuale e
collettiva dell’uomo contemporaneo, in cui via via
diventerà sempre più acuto un senso di malinconia e
meditatio mortis collegato a uno sfrenato e tragico
erotismo (I funerali di Togliatti, 1972; Caffè
Greco, 1976; Melancholia nova, 1980; La
visita della sera, 1982; Spes contra spem,
1982).
Per quanto poi riguarda più da vicino quello che con
Franco Russoli si può chiamare il suo “convulso
espressionismo mediterraneo”, sono tre gli elementi che
fanno perno nella sua pittura: a) un contatto sempre
pieno e dispiegato col mondo della natura sensibile; b)
una presa quasi tattile del suo oggettualismo, che con
Max Beckmann si può chiamare “autentico amore per gli
oggetti della apparenza intorno a noi e per i segreti
profondi della nostra vita interiore” [in una delle
Drei Briefe an eine Malerin, Tre lettere a una pittrice,
1948); c) un uso sempre acceso, passionale e vitalistico
del colore, che si può basare sia su accordi che su
dissonanze, fino a diventare all’ultimo simbolicamente
timbrico.
Queste note sull’arte di Guttuso sarebbero incomplete,
se non accennassimo a un’interpretazione psicoanalitica
su di essa, espressa da Dominique Fernandez. Il quale
vede nel bagherese il “primo, vero pittore siciliano:
ossia non soltanto nato in Sicilia, ma impregnato di
quella sicilianità che caratterizza tutti i grandi
scrittori dell’isola”. Guttuso, secondo Fernandez, non
dimenticherà mai “lo spettacolo barocco della lussuosa
policromia” dei mercati zeppi di merci (es. La
Vucciria), né l’origine infantile e popolare della
sua arte. E siccome, quando inizierà a dipingere, la
pittura italiana era ancora chiusa e scura, non avendo
avuto né i suoi Fauves né il suo Picasso, è lui
che finalmente “l’aveva aperta, scossa, maltrattata e a
volte malmenata, certo, ma riportata alla vita”. Però
egli “riuscì molto meglio con il registro negativo della
violenza subìta che con quello positivo della forza
operaia”. Come Vittorini, quello “ferito di
Conversazione in Sicilia, raccoglie il lamento di un
mondo offeso, più che esortare i proletari alla rivolta.
Il Guttuso migliore è rimasto
un
siciliano autentico, ovvero un cantore della tragedia e
della morte, della disfatta e del massacro, a dispetto
dei suoi principi rivoluzionari”. Insomma Guttuso non
avrebbe dipinto altro che Il Trionfo della morte
di Palazzo Abatellis [Renato Guttuso, siciliano,
Ibidem]. E forse, guardando a quanto Guttuso ha
fatto dal periodo introspettivo e memoriale in poi, in
particolare guardando al suo erotismo e alla sua
sensualità, si spiegano meglio malinconia e meditatio
mortis di gusto barocco (persino ne La visita
della sera la tigre è un simbolo di morte), perché
sono l’altra faccia della sua soggezione alle forze
istintuali della Grande Madre mediterranea.
GIUSEPPE MIGNECO
(Messina 1908 –
Milano 1997) emigra a Milano nel 1931 e inizialmente si
mantiene con lavoretti pubblicitari e come grafico alla
Rizzoli. Solo quando nel 1934 si mette in contatto con
Birolli e Raffaele De Grada, entrerà nel vivo della
pittura contemporanea. Nel 1937 è tra i fondatori del
movimento di “Corrente”. Nel 1939 partecipa alla prima
mostra del movimento alla sede della Permanente. Pur
praticando il realismo sociale come Guttuso, a
differenza di lui - che era organico al partito fino al
punto di rompere l’amicizia con Sciascia per restare
fedele alla “verità ufficiale” - Migneco fu sempre
autonomo e intellettualmente indipendente.
Nel 1942 parteciperà al Premio Bergamo con Cacciatori
di lucertole. Richiamato alle armi, potrà riprendere
la pittura solo nel 1945. Da quel momento si
susseguiranno le sue mostre, o le sue partecipazioni a
esposizioni collettive, in Italia e all’estero.
L’espressionismo mignechiano sarà sempre legato alla
tematica sociale della sua cerchia “realistica”
(pescatori, contadini, ecc.). Agli influssi vangoghiani
iniziali, subentrerà via via un suo modo tipico di
spaziare le figure, che lo ricollega da un lato al
muralismo messicano, e dall’altro a una caratteristica
tecnica del Fauvisme: quella di marcare gli spazi
interni con il cloisonnisme. Inoltre i fondi dei
suoi quadri vengono espressivamente “movimentati” in
vario modo: erbe, fiori, reti, pietruzze delle spiagge
o, quando mancano i richiami tematici espressi, con
strisce ortogonali. E’ per questo che Antonio Di Genova
ha definito Migneco “un intagliatore di legno che
scolpisce col pennello”, mentre “nei suoi paesaggi e
nelle sue figure c’è un’immobile atemporalità, che
richiama l’eco della tradizione decorativa e narrativa
dei carrettini siciliani, che ne riconduce l’opera ad
arcaiche radici mediterranee”.
SARO MIRABELLA
(Catania 1914 – Roma 1972) fa i suoi primi studi presso
un pittore locale (Saro Spina). Si trasferisce a Roma
nel 1936 e verrà accolto dal pittore Quattrociocchi, del
quale sposa la figlia. Frequenta l’Accademia di San Luca
e la scuola di nudo. Durante la guerra farà il
partigiano. Dopo la liberazione è assunto da Guttuso al
Liceo artistico, come assistente. Diventerà titolare per
concorso della cattedra di Figura disegnata, quella di
Guttuso, e sarà nominato direttore dello stesso liceo.
Fin dagli inizi è oppositore del “Novecento” e col
“Fronte nuovo delle arti” diventerà uno dei maggiori
esponenti del realismo. Nel ’49 si reca con Guttuso a
dipingere a Scilla. Parteciperà a quattro Biennali e a
quattro Quadriennali romane. Le sue opere, oltre che nei
musei italiani, sono anche al Puskin di Mosca.
Quello che caratterizza Mirabella è il suo oscillare fra
opposte tendenze: quella astratta iniziale del movimento
“Forma Uno” e quella realistica, incarnando in sé
l’anima del Ponte e quella del Cavaliere
Azzurro. Il suo è un astrattismo d’impianto
geometrico, nel quale risolve anche certi paesaggi in
cui le forme naturali sono riconoscibili (come farà il
primissimo Mondrian). Invece, dopo il periodo realista,
il ritorno all’astratto dal 1969 in avanti avrà una
strutturazione meno rigida che l’avvicina all’Informalismo.
La fase realistica è quella in cui il suo espressionismo
ha dato le prove migliori. Il suo colore, sempre molto
acceso, si basa su forti contrasti . La sua tematica non
concernerà soltanto i consueti contadini e pescatori, ma
ogni tanto avrà soggetti insoliti, come i “buoi
squartati” che richiamano Soutine (1953 e 1960).
Mirabella è stato anche un ottimo acquafortista.
|
|
4.
Artisti nati entro il 1910 |
|
ELIO ROMANO
(Trapani 1909 –
Catania 1996) è vissuto a Catania, dove frequenterà la
bottega di Saro Spina, come Mirabella e altri. La sua
vera formazione la farà a Roma , alla scuola del nudo e
come allievo di Felice Carena. Nel 1929 frequenterà
l’Accademia di Belle Arti di Firenze e le “Giubbe Rosse”
(Montale, Vittorini, ecc). In séguito andrà a Parigi,
spinto dall’amore per Bonnard e Cézanne. Ma allo scoppio
della guerra ritornerà definitivamente a Catania, dove
farà il docente all’Accademia di Belle Arti.
Oltre alle mostre prevalentemente in Italia, parteciperà
alla Quadriennale di Roma (’51, ’59, ’63 e ’71) e alla
Biennale di Venezia (’36 e ’50). La pittura di Romano si
caratterizza per la tematica della terra e del mondo
contadino dell’interno (in particolare fra Assoro e
Nissoria, nei monti Erei). Predilige il paesaggio e le
nature morte, anziché la figura. Rispetto all’iniziale
postimpressionismo che guardava a Cèzanne, la sua
pittura si fa più espressionistica in séguito, con un
dettato fortemente segnico. Romano resterà un solitario
isolato, in ciò indotto dal suo temperamento. Come ebbe
a dire di sé, “dipingo sempre le stesse cose e in fondo
sempre lo stesso quadro, anche se il soggetto è
diverso”. Frase che non è limitativa, ma esprime la
fedeltà a se stesso e al proprio mondo.
LIA NOTO in PASQUALINO
(Palermo 1909 –
Ivi 1998) è “il miglior pittore siciliano, dopo
Guttuso, della sua generazione”, come disse Raffaele De
Grada nel 1992. La sua casa palermitana sarà sempre
aperta ai visitatori e a quanti si interesseranno di
pittura d’avanguardia. Fa le prime esperienze col
futurista Pippo Rizzo. Dal 1937 al 1940 dirige una
propria e famosa galleria. Fece parte del “Gruppo dei
Quattro”, tra il 1932 e il 1937, con Guttuso, Nino
Franchina, e Giovanni Barbera. Ha partecipato alla
Biennale di Venezia (’42 e ’44) e alla Quadriennale di
Roma (’31, ’35, ’39 e ’48). La critica sottolinea nella
pittura della Noto una vena intimistica, che si
contrappone all’acceso colorismo guttusiano.
Secondo Vittorio Fagone, la pittrice “ha dipinto
ossessivamente delle figure, ha trovato il paesaggio
tardi, e poi ha dipinto sempre uno stesso paesaggio (gli
agrumeti e la propria casetta di campagna di Aquino,
sotto Monreale)”. In ogni caso la sua ricerca di
essenzialità e di semplificazione della forma è
ammirevole per i risultati che riesce a conseguire,
anche se la collocazione delle sue figure nello spazio
risente di una certa “primordialità”. Sulla pittrice
esistono due importanti monografie, edite dal Milione
(MI, 1974) e da Sellerio (PA, 1989).
GIANNI BECCHINA o GIANBECCHINA
(Sambuca di Sicilia
[AG] 1909 – Palermo 2001) fa i primi passi grazie a un
decoratore del suo paese natale, che lo assume come
garzone. Frequenta più tardi l’Accademia di Belle Arti
di Palermo e si accompagna agli artisti d’avanguardia
del “Gruppo dei Quattro”. A Milano conosce Beniamino
Joppolo e, suo tramite, entra in contatto col gruppo di
“Corrente”. Collabora come illustratore di strisce al
“Corriere dei Piccoli”. Parteciperà alla Biennale di
Venezia nel 1938 e nel 1954, quando con la Zolfara
vincerà il premio “Bevilacqua-La Masa”. Farà mostre
anche all’estero. Anche se in occasione della grande
retrospettiva agrigentina del 2007 il figlio
dell’artista, che dirige l’omonima fondazione che cura
il suo lascito pittorico, suddividerà la produzione di
Gianbecchina in otto sezioni, si può dire che la sua
pittura è contrassegnata sempre dalla tematica di una
certa sicilianità tradizionale (così come determinate
sezioni sono solo “per tema”: “Gli affreschi del sacro”,
“Il ciclo del pane”, ecc.). Si può aggiungere anzi che,
malgrado le frequentazioni giovanili con i pittori più
all’avanguardia, Gianbecchina resterà legato a una
pittura che rifiuta ogni sperimentalismo e, per certi
aspetti, rientra culturalmente in una “visione” della
Sicilia piuttosto arcaica e folcloristica, che trova
riscontro presso un pubblico pittoricamente meno
educato. Da questo punto di vista è, forse, la
“presenza” meno espressionistica.
|
|
5.
Artisti nati fra il 1911 e il
1920 |
|
GIUSEPPE MAZZULLO
(Graniti [ME] 1913 –
Roma 1988) è il primo degli scultori in cui ci
s’imbatte. Dal paese natio (nomen omen, si
potrebbe dire guardando al suo futuro) si trasferisce a
Roma nel 1939. E lì diventerà docente di scultura
all’Accademia di Belle Arti. Ricordiamo le sue
esposizioni alle Quadriennali romane ( ’35, ’39, ’43,
’47, ’51, ’55, ’59, ’63 e ’72) e alla Biennale di
Venezia (’50, ’52, e ’54). Ha anche esposto molto
all’estero, in Europa, in America e in Giappone.
Dice Guido Giuffré: “E’ noto come […] Mazzullo abbia non
tanto scoperto la pietra quanto si sia in essa
riconosciuto e da quel momento l’abbia privilegiata fino
ad adottarla in linea quasi esclusiva” [Mazzullo,
Mondadori, MI, 1985, catalogo per la mostra a Palazzo
Zanca di Messina]. Pur passando attraverso influssi
espressionisti e cubisti, Mazzullo – prosegue il critico
– “tendeva inconsapevolmente […] a una dimensione
primigenia e ancestrale”. Carattere che riscontra anche
Lucio Barbera, che parla di “respiro solido della
materia, da cui […] nasce l’impronta antica e moderna
che caratterizza le opere dello scultore siciliano, il
senso ‘arcaico’ che avvolge la sua scultura” [Mazzullo,
Ibidem]. Peraltro, a partire dagli anni Sessanta,
nella sua opera viene riscontrato un carico di
sofferenza, che si riferisce a una sfera panica e
archetipica.
In ogni caso Mazzullo non lavorò soltanto la “sua”
pietra lavica e il “suo” granito: al Museo
internazionale della Ceramica di Faenza si conserva un
suo pannello in ceramica (cm. 142 x 104) sul tema della
maternità, che vinse il premio Faenza del 1942. Infine,
dal 1981 esiste a Taormina, nell’antico Palazzo De
Spuches-S. Stefano del sec. XIV, un museo permanente
della sua opera, che conserva anche i disegni superstiti
della sua giovinezza, degli oltre 500 che esistevano
nella casa paterna di Graniti.
EMILIO GRECO
(Catania 1913 – Roma
1995) è l’altro scultore che vanta la Sicilia, la cui
grandezza si può desumere dall’affermazione che fece una
volta Picasso, come “il più grande disegnatore che
abbiamo in Europa”. La sua prima formazione avvenne
quando, tredicenne, entrò a lavorare nella bottega di
uno scultore di monumenti funerari, dove imparò sia a
sbozzare il marmo che a modellare la creta. Dopo una
lunga parentesi dovuta alla guerra, si fece conoscere
con le teste virili e con quel Lottatore
(‘47/’48) che richiamano gli esempi romani del I° sec.
a.C., come quelli di un Norbano Sorice e di un Lucio
Cecilio Giocondo. D’altra parte sia alla statuaria
romana che etrusca, più ancora di quella greco-classica,
la sua scultura guarderà sempre, anche se filtrerà il
suo modellato attraverso gli apporti derivanti dagli
esempi novecenteschi (si vedano esemplarmente le
torsioni e il restringersi e l’allargarsi delle forme in
Grande Bagnante n° I e in altre Bagnanti).
Realizzando comunque la nietzscheana alternanza fra i
principî apollineo e dionisiaco.
Greco lavorò prevalentemente la figura umana (il
Monumento a Pinocchio del 1956 resta un’eccezione)
e, nell’àmbito della figura, ebbe una preferenza per
quelle muliebri, tanto che Leonardo Sciascia ne
sottolineava la vena tipicamente e brancatianamente
catanese, quella del vagheggiamento della donna. Non si
contano le committenze famose, come la porta centrale
del Duomo di Orvieto (1961-64), gli altorilievi per la
chiesa dell’Autostrada del Sole (1961), il monumento in
bronzo a Giovanni XXIII per San Pietro (1965). Né
vanno dimenticati i lavori eseguiti per la committenza
estera, Giappone compreso.
Per Greco, e per la fama universale che raggiunse, è
anche fuor di luogo elencare le varie esposizioni che
fece durante la vita. Ci piace invece ricordare i vari
musei a lui dedicati, come quello di Catania (il più
recente), quello di Sabaudia dove il maestro riposa e
quello di Orvieto, senza dimenticare il museo all’aria
aperta di Hakone e le sale permanenti all’Ermitage di
San Pietroburgo e al Puškin di Mosca.
SEBASTIANO MILLUZZO
(Catania 1915) effettua le prime esperienze nello studio
del decoratore Cacciaguerra, ma è a Roma dal 1936 che fa
la scuola libera di nudo e si diploma al Liceo Artistico
nel 1939. Dall’anno successivo intraprenderà l’attività
didattica negli istituti medi e superiori. Negli anni
Sessanta fonda nella sua città la rivista “Sicilia
Arte”. Partecipa alle Quadriennali romane (’48,’51, ’56,
’60 e ’64) e alla Biennale di Venezia (’48, ’50 e ’56).
La maggior parte dei critici che si sono occupati di lui
ha sottolineato il suo continuo sperimentare attraverso
i media (oltre che pittore e incisore, è
decoratore e scenografo) e attraverso gli stili (persino
con un’astrazione ispirata dalla musica, come in
Concerto per piano e orchestra n° 19 di Mozart,
1995, e Beethoven Sinfonia Eroica, 1996). In
Le maniere di Sebastiano Milluzzo [Maimone Ed., CT,
1996] Giuseppe Frazzetto parla di arte “mercuriale”,
assimilando l’artista a Picasso. “Mercuriale sta per
pluralità di maniere (alla Giorgio Agamben, cioè
ciascuna come ‘esemplare’). Il polimorfismo stilistico
di Milluzzo […] può quindi ricondursi all’istanza
sostanzialmente personalistica che l’arte contemporanea
ci ha abituato a cogliere innanzitutto negli stili di
solito genericamente (e imprecisamente) definiti
espressionisti. […] E vano sarebbe chiedersi in quale
delle sue ‘maniere’ Milluzzo sia veramente se stesso. Lo
è in tutte”. Aggiunge Silvano Nigro: “Milluzzo sfugge,
proteiforme. E’ ‘una sola moltitudine’, alla Pessoa.
Libero nella sua realtà d’invenzione, può assumere mille
volti. Può essere uno e multiplo insieme”. D’altra
parte, intervistato da Carmela Gandolfo, dichiara egli
stesso che “cambiare continuamente prospettiva e punto
di vista fa parte del mio modo d’essere. […] A me sembra
che le tecniche siano differenti, ma che la mia
sensibilità artistica sia sempre la stessa”.
Sulla sua pittura , Renato Civello
[in Milluzzo, Lamda Editrice, CT, 1969] afferma
che egli “ha considerato con ammirazione il meglio di
Matisse e dei Fauves” e che nei suoi olî
“ricorrono agli inizi accenti mafaiani e scipioniani”.
Giuseppe Frazzetto segnala la sua “predilezione per un
geometrismo sui generis. […] Un’esigenza di
ordine, quindi, giacché la modulazione stilistica non
esclude affatto la lucidità d’analisi e la verifica di
una logica formale, e anzi le richiede, se non vuole
restare sospesa sul nulla del capriccio. […] La ricerca
di razionalità caratterizza anche il bianco e il nero
dei disegni, che spesso evitano qualsiasi accenno di
chiaroscuro e sembrano puntare piuttosto alla
mentalizzazione d’un esile tratto esclusivamente
lineare. […] Ma è nell’uso del colore che s’evidenzia
una fedeltà a quella rimeditazione di suggestioni del
Fauvismo e della Scuola Romana che caratterizza la sua
produzione dalla fine degli anni ’30 e dei primi ‘40”.
Per la scultura, Civello dice che
“sfugge alle tentazioni del filamentismo giacomettiano,
anche se, più che soffermarsi sul volume in sé,
l’interesse converge sul rapporto spazio-linea”. Mentre
Frazzetto afferma che “le sue sculture sono quasi sempre
‘frontali’, che secano lo spazio come se lo spazio fosse
costituito dall’interminabile sovrapporsi di superfici
(“un figurativo stilizzato fin quasi a giungere all’aniconico,
e con riferimenti totemici”, scrisse già una volta)”
Peraltro Milluzzo ha avuto modo di indagare questa
sicilianità dalle aperture mitiche sia in campo
religioso (celebre la Pala d’Altare per la catanese
Chiesa di Sant’Agata) che profano (Paladini,
Sull’Etna, ecc.).
SALVATORE FIUME
(Comiso [RG] 1915 –
Milano 1997) vinse a sedici anni una borsa di studio che
gli permise di frequentare l’Istituto d’Arte di Urbino,
dove conseguì una profonda conoscenza delle varie
tecniche grafiche. Nel 1936 approdò a Milano dove
conobbe Quasimodo, Dino Buzzati e Raffaele Carrieri. Nel
1938 si trasferì a Ivrea, presso la Olivetti (art
director di tecnica e organizzazione), e si
affiancherà a Franco Fortini e Leonardo Sinisgalli. Per
potersi dedicare interamente alla pittura, lascerà la
Olivetti e si trasferirà a Canzo, vicino a Como, dove
adattò ad abitazione una vecchia filanda.
Alla Biennale di Venezia del 1951, il suo trittico
Isola di Statue (ora nei Musei Vaticani) ottenne
molto successo e gli valse una commissione per le
riviste “Time” e “Life” di New York. Fra il 1949 e il
1952 compose a Perugia un ciclo di grandi dipinti
sull’antica gloria della città, richiamandosi a Paolo
Uccello e Piero della Francesca. Tali dipinti sono poi
stati donati dalla famiglia Buitoni, committente
dell’opera, alla Regione Umbria (ora al Palazzo Donini
di Perugia). Nel 1950 Giò Ponti gli commissionò un
dipinto (48 metri per tre) per le pareti del
transatlantico Andrea Doria, che a séguito
dell’affondamento della nave giace ora in fondo al mare.
Nel 1962 una sua mostra itinerante di centro quadri
toccò diversi musei tedeschi (fra cui Colonia e
Ratisbona).
Nel 1973, insieme col fotografo Walter Mori, si recò in
Etiopia (Valle di Babile, presso Harar) dove dipinse un
gruppo roccioso con vernici marine anticorrosione.
L’anno successivo, nella mostra antologica presso il
Palazzo Reale di Milano, espose la Gioconda Africana
(ora nei Musei Vaticani) e realizzò una sezione delle
rocce dipinte in Etiopia, che occupò quasi l’intera Sala
delle Cariatidi. Nel 1975 rivitalizzò gratuitamente il
centro storico della cittadina calabrese di Fiumefreddo
con varie opere. E dopo mostre al Principato di Monaco e
all’Accademia di Francia a Roma, fece nel 1983 un
viaggio in Polinesia per rintracciare le orme di Gauguin
(donando un proprio dipinto al Museo locale). Il suo
debutto come scultore (pietra, bronzo, resina, legno e
ceramica) avvenne a Milano nel 1994: sue statue
finiranno al Parlamento Europeo di Strasburgo, al San
Raffaele di Milano, al Museo di Portofino e a Marsala
(la Fontana del vino).
Fiume fu anche scrittore. Le sue opere, oltre che nei
Musei Vaticani, si trovano all’Ermitage di San
Pietroburgo, al MOMA di New York, al Museo Puškin di
Mosca e al Museo d’Arte Moderna di Milano. Sono due le
direttrici che caratterizzano l’opera di Fiume: una vena
fantastica e mitopoietica e una componente esotica e
primitivistica (ved. l’Etiopia e il viaggio sulle orme
di Gauguin ad Haiti). A tal riguardo, sono rimaste
famose l’Isola di Statue (1949) e la Città di
Statue (1950), dove le figure tondeggianti tendono a
porsi come feticci misteriosi e misticheggianti.
I motivi “orientali” e “africani” ritornano spesso: come
ne La visita del Pascià, in Dibattito sulla
donna, in Donna somala distesa, Donne al
balcone, Donne di Harar, Gioconda Africana, Mulatta in
giallo, Personaggio del teatro Kabuki, Ritratto
di cantante somala). Ma sono anche frequenti le
“rivisitazioni” di maestri del passato (De Chirico,
Picasso e il motivo del toro, Modigliani, Velasquez,
Goya e Raffaello).
Con PIPPO CONSOLI
(Mascalucia [CT]
1919) l’espressionsismo siciliano trova una delle sue
punte più rappresentative. Perché il temperamento
vulcanico e carsicamente effusivo dell’artista si sposa
alla sua grande cultura (sia figurativa che non).
Consoli infatti è storico dell’arte ed è stato
Sovrintendente alle Belle Arti.
Dal paese natio si trasferisce a Catania nel 1930. Fa
studi classici e conseguirà la laurea in Lettere
moderne, a indirizzo artistico, solo nel 1946, perché
richiamato alle armi e inviato a Rodi, viene catturato
dai tedeschi e internato in vari lager (da ultimo
a Wietzendorf). Da allora il lavoro alle Belle Arti lo
porta in varie città: Chieti, Milano, Agrigento,
Catania, Messina. Tramite Saro Mirabella partecipa alla
Quadriennale romana del ’48. Al Premio Suzzara nel ’50
vince un premio in natura con un disegno di Contadino
che si disseta. L’anno successivo partecipa ancora
al Premio Suzzara con Strage di Portella della
Ginestra, che verrà acquistato dalla Federazione del
PCI di Pescara per essere regalato a Giuseppe Di
Vittorio, e da questi sarà lasciato alla Segreteria
della CGIL di Roma, dove tuttora si trova.
Farà via via mostre in varie città. In occasione
dell’antologica di Catania del 1954, Leonardo Sciascia
dice della sua pittura: “In forza di una sua nativa
adesione a motivi culturali squisitamente siciliani, le
suggestioni e le esperienze più disparate della cultura
figurativa attuale, moderna, egli porta quasi sempre a
un punto di perfetta fusione la lezione di Picasso […]
Ma al di sopra di questo arcaico e istintivo vigore in
cui si risolve una cultura composita e dispersiva,
Consoli ha una qualità che è profondamente sua, il dono
di un’ironia, per così dire, in punta di penna” [Gazzettino
di Sicilia, RAI, PA, 3.12.1954]. E aggiunge Mimì
Maria Lazzaro: “La pittura di Consoli, nata da un
espressionismo letterario, si è andata incanalando verso
forme fauviste e cubiste, prelevando inconsciamente da
esse quel minimo di forma esteriore che gli serve per
raccontare a noi le sue favole e i suoi sogni con il
linguaggio scoppiettante del tempo” [La Sicilia,
CT, 4.12.1954].
Consoli si trasferisce a Milano nel 1959 e da allora la
sua ricerca si manifesta attraverso vari altri media
espressivi. Immagina innanzitutto delle strutture in
fibre metalliche (bellissima La capra) e poi
modella lamiere di ferro saldate (La danzatrice).
Da matasse tubolari di fertène policrome (un prodotto
della Montecatini) assembla particolari “accorpamenti”
che titola Ciclopi: consegue un vasto successo
alla Galleria “L’Indice” di via Santo Spirito. Seguirà
una fase “sociale” ripresa dalla cronaca violenta
(scippi, aggressioni, ecc.). Quando nel 1972 torna in
Lombardia, espone alla Galleria Pater di via Borgonuovo
(si ricorda: Gatto acciambellato, Ragazzo che gioca
con le nocciole), per la quale Carlo Munari dice in
catalogo: “Questo artista è vincolato alla Stimmung
della sua terra siciliana: a un fitto intrecciarsi di
solarità e di notturnità, di magnificenza barocca, e di
natura selvaggia, fascino di negre rocce vulcaniche e di
un mare ossessivamente azzurro […]. La figura del gatto
si propone come l’improvvisa apparizione di un animale
mitico, di un latore di messaggio arcano e insieme
enigmatico”.
L’ultima sorpresa Consoli la riserva nel 2000, con una
mostra di pure forme cromatiche, di immagini
fantastiche, che stando sulla soglia del conscio e
dell’onirico, scandagliano la freudiana categoria del
perturbante. Ma non si può chiudere il percorso
artistico di Consoli senza accennare all’attribuzione
che egli, come studioso, farà del palermitano affresco
del Trionfo della Morte ex Sclafani in capo al
maestro digionese Guillaume Spicre, che venne dipinto
nel 1462.
NINO LEOTTI
(Barcellona P.G. [ME] 1919 – Ivi 1993) è
un autodidatta che comincia a dipingere da ragazzo, ma
poi diventa ordinario di disegno e storia dell’arte nei
Licei Statali. Lascia la cittadina natale nel primo
dopoguerra, per trasferirsi dapprima a Milano e poi a
Roma. Rientra definitivamente a Barcellona nel 1959.
Durante il soggiorno a Milano raggiunge la Francia,
l’Olanda, il Belgio e la Danimarca. A Milano aderisce al
gruppo di “Corrente” e diventa amico di Peppino Migneco
e Beniamino Joppolo. A Roma frequenta Mazzullo, Guttuso,
Purificato, Zavattini e Stefano D’Arrigo.
A Messina fa parte degli artisti e letterati del
“Fondaco”, presso l’OSPE di Antonio Saitta, e perciò
frequenta S.Pugliatti, S.Quasimodo, Nino Pino Balotta,
Vann’Antò ed altri. E’a lui che viene l’idea di
allargare questo sodalizio anche alla gastronomia e
diventa così il cuoco “ufficiale” del “Fondaco” (la sua
specialità era la ghiotta di stoccafisso).
Espone la prima volta nel 1947 a
Barcellona (ebbe come maestro un incisore palermitano
vissuto negli USA, Vittorio Drago). Numerosissime la
mostre personali e collettive. All’estero ha tenuto
personali ad Amburgo, Zurigo, Copenaghen, Amsterdam. Ha
partecipato alla Quadriennale di Roma del 1951/52.
Afferma Michele Spadaro [Catalogo,
Mostra a Patti, dic. 2002] che è da sottolineare nella
sua pittura “l’uso del colore, personale, creativo,
carnalmente acceso; l’ironia del racconto, motivata da
una sottile critica all’ambiente provinciale; l’aspetto
umano, estrinsecato emotivamente anche attraverso la
ricerca di tratti caricaturali; il realismo figurativo,
frutto di interpretazione interiorizzata del mondo”. Del
pari Elio Anastasio [Catalogo, Mostra a
Castroreale, luglio 2001] dice che il “suo figurativismo
è un figurativo soggettivo, nel senso che i suoi
soggetti non sono mai presi dal vero. Leotti non dipinge
ciò che vede, bensì ciò che sente”.
E’ stato spesso sottolineato che
l’espressionismo di Leotti è affine a quello di Migneco,
con il quale si accompagnò sempre. Tale affinità è
evidente negli sfondi delle tele, che sono “variegati”
come quelli mignechiani (muri a secco, ciottoli, foglie,
cactus, ecc.). Ma mentre in Migneco c’è una maggiore
varietà tematica (famoso, ed emblematico, il “ragazzo
accoccolato” che fa i propri bisogni), in Leotti
l’umanità rappresentata è più “localistica” (è tipico il
suo ombrello rotto, trovato abbandonato in una spiaggia
e “ridiventato vivo, perché gli aveva dato un’anima”).
In ogni caso, come afferma egli stesso nell’intervista
rilasciata a Sergio Palumbo [RAI/2, aprile 1990], lo
“scambio fu reciproco: io subivo il suo influsso dal
punto di vista grafico, lui invece lo subiva dal punto
di vista cromatico”.
RENZO COLLURA
(Grotte [AG] 1920 –
Palermo 1989) fu il prestigioso direttore della Galleria
d’Arte Moderna di Palermo dal 1959 al 1977 (ubicata dal
1910 al 2006 presso il Teatro Politeama). Compie i primi
studi artistici a Torino, ma in séguito alle vicende
belliche opererà in un primo tempo in Grecia e poi in
Albania, dove per la conoscenza dell’arte classica e
bizantina sarà incaricato dal Ministero per la Cultura
popolare a organizzare e dirigere corsi di avviamento
artistico.
Per rigore etico farà conoscere le opere della sua
attività di pittore solo dopo il suo collocamento a
riposo. Da allora terrà mostre a Palermo, a Padova, Roma
e in altre città. Nel 1999 il Comune di Grotte gli ha
dedicato una grande retrospettiva. Quello che
caratterizza l’arte di Collura è la componente
fantastica, che gli fa assemblare elementi monumentali e
paesaggistici in composizioni con grandi linee curve e
spazi delimitati ma allusivi. Inoltre la sua tavolozza
usa accostamenti insoliti, come il nero che a volte
marca in maniera aggressiva le composizioni.
|
|
6.
Artisti nati fra il 1921 e il
1930 |
|
MARIO BARDI
(Palermo 1922 –
Milano 1998) ha dapprima insegnato materie artistiche ad
Aosta nel 1951, poi ha vissuto a Torino e infine, dal
1958, a Milano. Qui, frequentando le personalità più
rappresentative in campo artistico e critico, ha poi
vissuto e si è affermato (rimase famoso il suo spazio “Aleph”,
sorto nel 1982, in un cortile di Corso Garibaldi). Ha
esposto in varie gallerie italiane e qualcuna anche
all’estero (Helsinki, Polonia, Berlino). Il suo periodo
realistico fino agli anni Cinquanta risente della
lezione cèzanniana, mentre quello “esistenziale” degli
anni Sessanta è sottoposto alle sollecitazioni della
cronaca (Il mulo tra le macerie allude al
terremoto del Belice e Suez ’67 alla crisi
mondiale di quel momento ed è forse per questo che il
dipinto è risolto in tonalità di rosso).
Ma è con la “nuova figurazione” dagli anni Settanta in
avanti che Bardi trova la sua “sigla” più propria, che
può andare da citazioni di maestri del passato (es.:
Omaggio a Velasquez del 1974/77) a una rivisitazione
dei motivi dell’opulenza barocca e magniloquente della
“sua” Palermo, come Cardinali (1976) e Viceré
(1978), tutti dipinti caratterizzati dalla scomparsa del
volto delle figure. Bardi poi, nel 1980, si rifà all’allegorismo
di Guttuso e, in una grande composizione chiamata
Giardino, mette insieme vari personaggi della sua
epoca (c’è Marilin Monroe), se stesso (l’autoritratto in
primo piano) e, seduti sulla destra a un tavolino,
Guttuso e Sciascia.
SANTO MARINO
(Militello Val di
Catania [CT] 1922 – Ivi 1991) frequentò il liceo
artistico di Palermo, dove si diplomò nel 1947. Qui ebbe
modo di conoscere i pittori che gravitavano intorno alla
cerchia di “Corrente” e da allora l’aspetto sociale e
l’impegno politico non abbandoneranno mai la sua
pittura, che d’altra parte trova nel mondo contadino del
suo paese la fonte principale d’ispirazione. Nel 1959
partecipa a Vienna alla mostra internazionale della
“Giovane pittura italiana” e nel 1964, su invito del
governo della Germania Orientale di allora, terrà una
personale di disegni a Berlino e di altre opere a
Dresda. Anche l’anno successivo partecipa a una mostra
internazionale di grafica a Lipsia. La Germania, insieme
con la Polonia, conserva molte sue opere.
Marino in vita ebbe contatti con l’intellighenzia
di sinistra e non tradì il suo mai sottaciuto scopo di
“trasformare”, e perciò di lottare contro le condizioni
sociali oppressive delle classi più umili e diseredate.
Fece scalpore la sua tragica fine: travolto da un treno
per disattenzione, mentre camminava sulla linea ferrata.
Fin dall’inizio la sua pittura fu definita come
“espressionismo mediterraneo”, per l’alterazione delle
forme e i violenti accostamenti di colore. Forse oggi, a
distanza di tempo, certa sua tematica appare troppo
gravata con le lotte per il “riscatto” dei suoi
contadini. E’ però fuor di dubbio che il rispecchiamento
che egli ha fatto di una determinata realtà di Militello
sia icasticamente rappresentativo di un clima e di
un’epoca. Il suo paese natale, giustamente, gli ha
dedicato una sala permanente nel Museo Civico.
PIPPO BONANNO
(Palermo 1925)
è un autodidatta che ha iniziato a disegnare molto
presto e, inizialmente, farà vignette per i giornali
satirici (“Il becco giallo”, ecc.). Nel 1947 inizia la
carriera di insegnante a Moncalvo Monferrato. A Torino
guarderà a Casorati e a Spazzapan, ma poi resta
folgorato da Picasso. La prima personale avverrà a
Palermo nel 1958 alla Galleria Flaccovio. Espone poi a
Milano nel 1960 e, successivamente, farà il suo percorso
in Italia e all’estero. Intensità del colore,
deformazione espressionistica e partecipazione emotiva
sono gli elementi intorno a cui si struttura la pittura
di Bonanno che, anche se inizialmente trova pause più
liriche, si caratterizza sempre più attraverso il
grottesco.
La sua tematica passerà così da vari cicli: “i
generali”, “i cardinali”, “le memorie barocche”.
L’obiettivo resta sempre lo stesso: demistificare il
potere incarnato e la superstizione che avvolge le
menti. Se si prendono i “generali”, sembra quasi di
assistere a una combinazione di vari maestri: il
grottesco di George Grosz, l’allucinazione dei derelitti
di Lorenzo Viani e l’esteriorità in divisa e con le
medaglie di Enrico Baj. Come dirà egli stesso in una
dichiarazione del 2005, la sua pittura ha per tema “gli
emblemi assurdi del degrado politico e morale”. Ciò
peraltro non significa che Bonanno non faccia poi
“sosta” su momenti più pacati e di più rasserenante
“memoria”, come quando ripercorre il “mito” di Racalmuto,
dove aveva origine la sua famiglia. Negli ultimi tempi
la pittura di Bonanno, a parte la rivisitazione della
tradizione religiosa, sfocia in una sorta di in
formalismo, che sembra richiamare motivi vegetali e
naturali.
BRUNO CARUSO
(Palermo 1927)
incominciò a disegnare sotto la guida del padre
ingegnere, dall’età di cinque anni (copiando opere di
Leonardo, Pisanello e Mantegna). Frequentò il liceo
classico e si laureò anche in giurisprudenza, anche se
poi fece dei corsi liberi all’Accademia di Belle Arti.
Vive e lavora a Roma dal 1959.
Caruso ha molto viaggiato: nel 1947 a Praga, a Monaco e
a Vienna (eseguirà un ciclo di disegni ispirati a Gorge
Grosz, dal titolo Deutschland uber alles,
riproduzioni delle opere di Klimt e Schiele, e studierà
in particolare Espressionismo e Secessione Viennese).Tra
il 1945 e il 1950 è a Parigi e a Londra e si fermerà per
molto tempo a Milano, diventando amico di Vittorini e
Quasimodo. Ma è in Sicilia che, diventato amico di
Girolamo Li Causi e di Leonardo Sciascia, si eserciterà
sempre più nella denuncia delle condizioni sociali del
mondo contadino e nella lotta contro la mafia (ved.
L’occupazione delle terre incolte e Portella
della Ginestra). Negli anni ’60 collabora anche con
“L’Ora” di Palermo e s’impegna nella grafica per
l’editoria (non va dimenticato che Caruso è anche
scrittore, sia di libri sull’arte che non). E’ anche per
questo che, nella grande mostra palermitana del 1973
presso la Civica Galleria d’Arte Moderna, sono stati
presentati i vari scritti e i libri da lui illustrati.
La produzione di Caruso è sterminata, ma c’è una
caratteristica che contrassegna la sua opera: un segno
marcatissimo, spesso di genere grottesco alla Grosz, che
tecnicamente può variare dalla vera e propria grafite,
all’inchiostro di china o alle classiche acqueforti. E
anche quando affronta l’acquarello e i colori a olio, il
disegno in lui tende sempre a prevalere. Naturalmente,
la tematica della sue opere è prevalentemente ispirata
alla Sicilia, anche se spesso non sono i soggetti
“reali” a essere trattati, ma quelli reinventati
attraverso il filtro memoriale.
D’altra parte, ebbe a dire lui stesso: “La memoria di un
pittore è essenzialmente figurativa e la mia è
particolarmente esercitata a ricordare le immagini
(tanto che tutto quello che disegno o dipingo lo faccio
a memoria) e queste immagini si accavallano come in un
film […]. Ma sono pur sempre memorie di fatti e di
sequenze di fatti; eventi che poi un pittore è costretto
a sintetizzare in una sola immagine e mistificare o
nascondere in una metafora spesso sibillina o ambigua” [Motta-Caruso,
Un’amicizia, Manduria, 1994]. E metafore,
sibilline o ambigue, sono spesso le sue immagini, come
quella del grande falcone che guarda, in un panorama
dello Stretto di Messina ripreso dalle crocifissioni di
Antonello, Leonardo Sciascia che avanza nudo su un
cavallo; oppure il grande ficus dell’Orto Botanico di
Palermo, dalle radici pendule, intriganti e aggressive,
che simboleggiano la “piovra” dell’Inquisizione
siciliana.
GIUSEPPE GAMBINO
(Vizzini [CT] 1928 - Preganziol [TV] 1997) fu un girovago perché il padre,
funzionario alle Belle Arti, veniva trasferito in varie
parti d’Italia. Cominciò a darsi all’arte fin dal 1944,
sull’Appennino modenese, che com’è noto fu sede di aspri
scontri fra tedeschi e partigiani. Fu giocoforza,
allora, comporre e seppellire i corpi dei caduti. Nel
1953 arriva a Bologna e si occupa di grafica
pubblicitaria insieme con Nino Caffè. Dal 1954,
spostandosi a Venezia, si dedicherà definitivamente alla
pittura.
Tenne la sua prima grande esposizione alla Fondazione
Bevilacqua La Masa e da allora venne consacrato come
“pittore veneto”. Seguirono esposizioni in Italia, negli
Usa e in Europa, fra cui Cordoba, dove trascorreva ogni
anno l’inverno. Dal 1963 acquistò e ristrutturò
un’abitazione colonica a Preganziol, dove poi si spense,
e perciò la mostra che si tenne a Treviso, sul tema
“Venezia”, è sotto un certo aspetto “dovuta” come
riconoscimento della sua terra d’elezione.
La sigla più caratteristica dell’espressionismo di
Gambino è da vedere nelle facciate , nei palazzi e nelle
chiese veneziane, dipinte con forti contrasti di colori
e con una composizione figurativa piatta e schiacciata
contro il fondo, che però ricerca accordi e suggestioni
di tipo musicale. Esemplari, in quest’àmbito, Le
Procuratie vecchie del 1960 e La chiesa della
Salute del 1996.
MICHELE SPADARO
(Santa Teresa Riva
[ME] 1929 ) è un autodidatta (solo da ragazzo prese
lezioni di disegno “rappresentativo” da una pittrice).
Di lui ha detto Leonardo Sciascia: “Medico per necessità
di vita, pittore per elezione di natura”.
Sul suo luminismo ha
insistito Mario Monteverdi: “Spadaro ha inteso il colore
in funzione della luce, ossia ha superato le suggestioni
immediate fornite dal colore per servirsi di
quest’ultimo come di un mezzo per realizzare la luce.
[…] Sicilia non più e non tanto come folclore […] ma
come realtà lirica. […] La natura […] viene
interpretata: più precisamente nella sua poetica
essenza” [Catalogo, Galleria Angolare, MI, 1970].
E aggiunge al riguardo Sergio Palumbo: “ Spadaro non ha
subito una dichiarata influenza delle avanguardie
storiche protonovecentesche, né di quel realismo sociale
del secondo dopoguerra così fortemente sentito, invece,
da pittori siciliani che hanno fatto scuola come Guttuso
e Migneco. Una ideale ascendenza si può, semmai,
riscontrare nell’opera di macchiaioli e chiaristi, ma
Spadaro guarda al paesaggio siciliano con sensibilità
moderna. […] Pure là dove questa sua Sicilia, difatti,
sembra apparentemente fuori del tempo, arcaica e rurale,
inanimata per l’assenza o quasi di umanità, c’è a monte
l’idea di un totale rifiuto della realtà industriale e
consumistica. […] Quella che egli mostra è in sostanza
l’immagine cristallizzata di un mondo più sognato che
vero, ci si trova allora dinanzi a una dimensione più
simbolica che realistica” [Catalogo, Mostra
Comune di Milazzo, 1993].
Anche Lucio Barbera sintetizza in questi termini la sua
visione pittorica: “Spadaro è di sua natura un artista
lirico e, sotto il profilo formale se si vuole, un
‘chiarista siciliano’, che è cosa ben diversa dal
chiarismo che ebbe fortuna in Lombardia intorno al 1929
con artisti quali Del Bon, De Rocchi e Lilloni. La
liricità di Spadaro si impianta in una ossessiva e
dolcissima visione di una Sicilia del tutto diversa da
quella di artisti quali Guttuso o Migneco. […] Spadaro
piuttosto guarda ai grandi
spazi, a quelle sensazioni omeriche di classica
compostezza, a un ordine possibile della natura non
scempiata dall’inquinante presenza umana, a quel tempo
più alto dell’orologio […] che governa le stagioni. C’è
nella sua pittura questo respiro quasi epico che punta
alla bellezza non contaminata,non alle cose ma alla loro
resistenza” [Gazzetta del Sud, 29.1.1993].
|
|
7.Artisti nati dal 1931 in
avanti |
|
ERNESTO LOMBARDO
(Tripi [ME] 1934) si
è diplomato all’Istituto Statale d’Arte di Palermo. Fa
le prime esperienze artistiche a Messina, ma verso la
fine degli anni Sessanta si trasferisce dapprima a
Milano e poi ad Albissola. In séguito va a vivere a
Roma. Numerose le mostre personali e collettive in
Italia e all’estero. La pittura di Lombardo si inscrive
in una decisa linea fantastico-visionaria, come ha
sempre messo in rilievo la critica. Renzo Margonari
precisa che la sua visionarietà “si costruisce senza
deviare dal dato reale di base. Non siamo […] nel campo
della fantasticheria, nella sua variazione di ‘capriccio’,
ma piuttosto nel campo del visionario, detto in senso
goyesco”. Pippo Consoli parla di “estasi metafisica, la
quale costituisce in atto la sigla essenziale dell’opera
di Lombardo […]. Il suo discorso si svolge nella
rappresentazione inquietante quanto plausibile di
sibilline metafore. […] Lombardo assume la difesa
del culto romantico della natura che la moderna civiltà
degrada”.
Paolo Miccoli afferma che “la costante della pittura di
questo artista è data essenzialmente dalla visione
simultanea di natura e storia. La natura prende corpo
nel fascino del mare, dei monti, degli alberi, del cielo
e dei prati, mentre la storia palesa i suoi documenti o
‘frammenti del passato’ in statue dimezzate, in reperti
archeologici, in attestati plastici della mitologia
pagana. La cifra dell’arcaico […] è anche lezione di
richiamo alla saggezza del passato ideale, dove
l’armonia della natura non era messa in crisi
dall’operato dell’uomo tecnologico odierno”. Renato
Civello aggiunge: “Il dato naturalistico (grande
carrubo, roccia, stoppie riarse, collina o ansa di mare)
è investito di un misterioso respiro. La metafisica è in
agguato, ma senza la rarefatta idealità dell’invenzione
dechirichiana”.
Emilio Sidoti [sulla rivista Liguria, n° 4, aprile
1992] afferma: “Gli ultimi dipinti […] sembrano
variazioni di un medesimo tema scandito in tre momenti
fortemente metaforici: il verde residuo, la landa
desolata ed il mare lontano. […] In essi domina il
vuoto, incombe l’assenza, il silenzio. […] Lombardo non
dipinge paesaggi, ma dà corpo a pensieri, riflessioni,
stati d’animo: le sue sono visioni e non paesaggi. […]
Il suo è un romanticismo senza illusioni, aprés le
dèluge”. Claudio Strinati dice che “le sue opere
sono contemplazioni immobili di luoghi che non esistono,
ricostruiti da una personale ‘arte della memoria’. Tutti
gli elementi che compongono quei luoghi sono reperibili
nella realtà della natia Sicilia ma niente viene
rappresentato dal vivo. […] Tutto si cristallizza
davanti ai suoi occhi nelle forme di un eterno
presente”. Mario Lunetta [sulla rivista Roma,
1993] vede “nel sogno della Sicilia archetipica di
Lombardo […] un teatro di finzioni di secondo grado, un
metateatro. […] E quest’invenzione desublimatoria e
lievemente sarcastica […] rimescola con solenne capacità
di sospensione e di inquietudine contemporanea
suggestioni ‘metafisiche’ e ‘surrealiste’, dentro una
zona di immobile ciclone barocco”.
Maria Augusta Baitello infine scrive: “Il mito, la
storia, la favola fanno parte […] della cultura di
Lombardo. […] Paesaggi a volte disabitati e a volte
popolati da insoliti ed arcani protagonisti: personaggi
mitici, animali, sfingi, statue. […] Figure e spazi
sospesi a metà, collocati sulla soglia di un
oltre-realtà capace di coniugare il dato irreale con
quello reale. […] In un tempo teso all’infinito e per
questo ultramondano, in grado però di ospitare i miti di
ieri rivisitati dalle necessità dell’oggi”.
PIPPO GAMBINO
(Porto Empedocle [AG] 1935 – Palermo 2004) si
trasferisce con la famiglia a Palermo già a quattro
mesi e – predestinazione ? – in una casa le cui
finestre aggettano sull’Accademia di Belle Arti. In
effetti Gambino frequenta il Liceo artistico e, nel
1952, si iscrive all’Accademia, dove verrà assunto come
assistente nel 1955. Poi nel 1960 vince il concorso per
la cattedra di “Incisione”, le cui tecniche eserciterà
per tutta la vita con risultati importanti (e
innovatori, come la stampa su papiro e quella su
sughero). Per Gambino bisogna perciò usare sempre la
doppia denominazione pittore-incisore.
Peraltro, la carriera artistica si affianca sempre a
quella di insegnante: diventa direttore dell’Accademia
di Palermo nel 1978, ma insegnerà anche a Bari (1977) e
inviato come commissario all’Aquila (1984). Sarà
incaricato dal Ministero a integrare gli organici per
l’Accademia di Sassari (1988). Questa collaborazione
“ministeriale” culminerà nel conferimento della medaglia
d’oro per meriti culturali da parte del presidente
Cossiga (1990). E quando nel 1982 si trasferisce a Roma,
assumerà la cattedra all’Accademia “libera” di Ripetta
(e vivrà in una soffitta-laboratorio sita in un ex
convento, a Trastevere).
Pippo
Gambino, già nel 1953, compie viaggi di studio in Europa
(Parigi, Salisburgo, Saarbrucken, Monaco) e, via via,
espone spesso all’estero (Stuttgard, Mosca,
S.Pietroburgo, Kiev, Talvin, Londra, Berlino, Città del
Messico, Ankara e Smirne, New York). In Italia, a parte
le mostre in varie città (e i premi assegnatigli),
espone alla Quadriennale di Roma nel 1960 e nel 1986.
Leonardo Sciascia, che come si sa era un “amatore di
stampe”, loderà nel 1966 la sua “volontà di fare
l’acquaforte, di esprimersi compiutamente nei limiti e
nell’identità del mezzo che si è scelto”. Ma già Renato
Guttuso, nel 1964, descriveva la sua arte in questi
termini: “La sua pittura è fatta di caratterizzazioni di
tipo espressionista: il sentimento della sofferenza si
esprime attraverso la deformazione dei volti, del
paesaggio. Bisogna però osservare che la ‘deformazione’
espressionistica non è in Gambino qualcosa di
volontario, di sovrapposto all’immagine normale, ma
connaturata ad essa: il paesaggio, ad esempio, subisce
le stesse deformazioni di un volto. Il tema di Gambino è
il dolore: delle case, mura, tetti, imposte, alberi,
radici, volti”.
Di neo-espressionismo parla il critico Franco Grasso (L’Ora,
PA, 1.11.1972) e Aldo Gerbino, in un bell’articolo del
2004 (Prometheus, PA, n° 81) usa per le sue
figure l’espressione dismorfia cinematica dei corpi.
Mai come in Pippo Gambino torna d’attualità quello che
diceva G.C.Argan: “Il brutto non è altro che un
bello caduto e degradato. […] Soltanto l’arte
potrà compiere il miracolo di riconvertire in bello
quello che la società ha pervertito in brutto”
[in L’arte moderna, citato]. Spesso infatti le
figure di Pippo Gambino sono la quintessenza della
“bruttezza” e di una ricercata e guttusianamente
“dolorante” umanità. Figure di frequente collocate
contro uno sfondo di macerie e di ruderi (si possono
prendere, emblematicamente, gli stessi titoli di certe
sue incisioni: Viscere (1950), Sventramenti
(1954), Cortile Cascino (1953), come se Palermo
non potesse che mettere in mostra i suoi “segreti”
innominabili. C’è poi nei suoi paesaggi una ritornante
impostazione a fasce orizzontali, bi o più spesso
tripartite: dove, nel primo o più di frequente ultimo
piano, campeggia un grosso mammellone roccioso che
sembra richiamare vagamente i paesaggi australiani, le
tipiche Hanging o Ayers Rocks.
NINO
CANNISTRACI (Roccavaldina
[ME] 1935) insegna progettazione e costume in una Scuola
d’Arte della sua città . Oltre alle mostre in Sicilia,
ha esposto a Innsbruck nel 2001 e ad Ankara nel 2005.
Il critico che quasi a ripetizione
si è occupato di Cannistraci è Guido Giuffré, che già
nel 1973 affermava: “La natura dell’artista siciliano,
contrastante con la mitezza del suo carattere, è intrisa
di un senso drammatico del mondo, radicale e senza
compensi […].E’ una drammaticità giuocata su accensioni
formali di tipo espressionistico, ma non vangoghiano
[…], quanto piuttosto espressionismo ancora giudicante,
nel quale una vena di psicologismo visionario
centroeuropeo scorre sotto l’irruenza mediterranea. E’
una drammaticità, inoltre, il cui senso panico non si
traduce mai in esiti di action painting o
variamente gestuale, ma sempre si avvale di una
plasticità della forma. […] Se si analizzano le
confluenze nell’arco della pittura contemporanea ecco,
coerentemente, Sutherland e Bacon come Picasso. Ma ecco
soprattutto il volto autonomo […] di una pittura che non
si nutre di prestiti ma di un clima problematico”. E nel
1977 precisava: “Intanto il colore non offre la vivacità
che ci si aspetterebbe da un meridionale. E’ colore
sottile, filtratissimo […]. Eppure è colore caldo […],
dissolto negli spazi protagonisti […]. Spazi senza suoni
dove una forma può disfarsi come capriccio di nuvola”:
E nel 1986 aggiungeva infine: “Sui contenuti poetici non
sono intervenuti novità di rilievo; l’artista tenta,
tormenta, scava negli aspetti di una dimensione
culturale tanto universale […] quanto puntualmente
siciliana, che in letteratura, da Pirandello a D’Arrigo,
ha immediati riscontri; e nell’arte figurativa […] una
visionarietà spinta alla disperata o cupa follia,
abissale solitudine, suggestiva confidenza col mito”.
Anche Lucio Barbera [Il mito
quotidiano, in Nino Cannistraci, opere, Gall.
D’Arte L’Airone, ME, dic. 1990] ricalca tali giudizi e
sottolinea che “la carica fantastica, che lo conduce sia
alla deformazione della realtà, che alla affermazione di
impossibili coesistenze allegoriche […], non spinge mai
la sua pittura sul terreno della surrealtà”. Mentre
Elvira Natoli (1986) mette l’accento sull’aspetto
polisemicamente simbolico della sua pittura: “Una
figurazione costruita in addensarsi drammatico della
stesura cromatica indaga mitiche forme, registra
affiorare di pensieri intorno ai misteriosi e ambigui
meccanismi del reale (donna, specchio, babuino,
sparviero), simboli arcani, minacciose presenze”.
Ma chi più di tutti ha messo in
evidenza la natura simbolico-archetipica, alla Jung,
della sua pittura è lo stesso pittore, che in un’autodichiarazione
del 1974 afferma: “Faccio una pittura che si potrebbe
anche definire tradizionale, se non fosse per
l’esecuzione tecnica che è essenzialmente
espressionistica […]. Nei miei quadri si possono trovare
belve e crocifissi, nudi femminili e babuini, avvoltoi,
presenze insomma del mondo naturale, spesso zoologico, e
simboli di altra natura attinenti al mondo spirituale.
L’associazione di questi elementi non è mai programmata,
ma nasce sempre da una sorta di evocazione spontanea per
antitesi fra Eros e Thanatos. […] Queste forme naturali
diventano così, attraverso i processi autoanalitici,
archetipi dell’inconscio. […] L’arte non esprime mai il
proprio rapporto col mondo e con la storia in forma
diretta, ma sempre attraverso metafore, che è proprio
quello che io cerco di fare”.
GIGI
MARTORELLI (Palermo 1936) frequenta dapprima il
Nautico e poi il Liceo Artistico. Si iscrive
all’Accademia B.A. ed è attratto da Pippo Rizzo. Nel
1957 va a Milano e viene accolto da Peppino Migneco. Si
diploma all’Accademia nel 1959 e, tramite Giorgio
Carpintieri, ottiene una committenza per la decorazione
di negozi. Dal 1962, e per otto anni, insegna al Liceo
Artistico di Palermo. Nel 1970 lascia l’insegnamento e
si trasferisce a Roma. Ma nel 1980 decide di esiliarsi a
Capo d’Orlando per avere un contatto più diretto con la
natura e col mare (vive con una merla indiana, di nome “Ciccina”).
Fa la prima personale nel 1962 alla
Galleria Flaccovio di Palermo. Da allora espone in varie
gallerie, prevalentemente siciliane (all’estero a
Maracaibo nel 1959 e a Caracas nel 1972).
Afferma Anna Maria Ruta [in Gigi
Martorelli, Sellerio, PA, 1991]: “Sul finire degli
anni Cinquanta la pittura di Martorelli si articola tra
un ‘astrattismo inquieto’ […] che ammicca a Kandinskij e
varie coloratissime Forme (sagome di paesaggi
urbani ed extraurbani, ma anche gli oggetti e gli
elementi di una natura morta, […] come tenaglie, pinze,
barattoli, contenitori, tubi di colore, pesci, limoni,
ecc.), che rivelano la tensione verso una ricerca che è
prevalentemente formale e cromatica”. Verso gli anni
Sessanta inaugura la stagione dell’Informale (da Vedova
ad Hartung, da Fautrier a Pollock), ma ben presto
“approda – continua la Ruta – a un suo particolare
neo-figurativismo (che richiama anche il suo amatissimo
Bosch) e più tardi il recupero della realtà si
stabilizza in forme assai personali, attraverso
l’incidenza della luce su forme emblematiche”. Il suo
sperimentalismo adotterà anche l’uso della sabbia
mescolata ai colori, in particolarissime tecniche
miste.
Eva Di Stefano sostiene [in A
lemon is a lemon is a lemon, Ibidem] che “i tre
principali moduli compositivi che ricorrono nei trent’anni
di pittura di Martorelli, lo spacco, l’orizzonte e
l’ingranaggio, sono combinati insieme nel Racconto
della terra e della luna spezzata (1984)”. Per lo
spacco è emblematica l’opera Avventura del limone
(1974), dove la ripetizione seriale del frutto è – come
afferma lo stesso Martorelli – ‘una forma che vive di se
stessa’ e diventa perciò “una dichiarazione di poetica
per un pittore a briglia sciolta che in tutto il suo
lavoro ha alternato con spregiudicata naturalezza
immagini figurative e astratte”. Per l’ingranaggio, in
“quell’aggrovigliarsi di oggetti, tubi, rottami,
recipienti, sassi, detriti, membra disarticolate,
riconosciamo una sorta di moderno inferno alla Bosch, un
mondo di mutilazioni metalliche, di deriva tecnologica
[…], che […] è anche semplicemente […] un incubo
dell’anima, un cattivo sogno”. Per l’orizzonte, infine,
“credo che alla passione degli artisti siciliani per la
linea dell’orizzonte (si pensi a Guccione) non sia
estranea nel fondo una drammaturgia dell’insularità
ovvero del limite”.
Vincenzo Consolo [in La risacca
di Gigi Martorelli, Ibidem] scrive: “Cosa
vuole raggiungere, cosa vuole riconquistare Martorelli a
Capo d’Orlando? Non certo la natura. Non è così ingenuo
il pittore, da credere che la natura possa ancora essere
rappresentata, sia pure come nostalgia, come utopia. Noi
crediamo che da Capo d’Orlando egli abbia voluto
ripartire proprio per registrare, per dipingere l’agonia
di essa, la sua fine. […] D’altre risacche vuole dirci
il pittore, d’altri detriti. Forse della nostra anima,
della nostra epoca, della condizione umana”.
Franco Grasso [in L’Ora, PA,
12.4.1974] afferma: “Per spiegare la ‘pittura ecologica’
di Gigi Martorelli non è difficile rinvenire […] i
riferimenti al paesaggio siciliano, ma con una
ribellione costante al piacevole e al caratteristico, al
cliché della Sicilia felice come agli schemi veristici e
sociali. La chiave di tutto il fare dell’artista è da
ricercarsi in un rapporto di amore-odio – verso la
Sicilia, verso la natura, verso la società, verso il
mondo intero -, che si è andato con gli anni esasperando
sino a spingersi talora ai limiti della furia
iconoclasta, del satanismo distruttivo”.Anche se Eduardo
Rebulla [in L’Ora, PA, 12.3.1975] attenua questa
negatività affermando che “alla coscienza di una natura
inabitabile come riflesso dilatato del proprio stato di
alienazione e costrizione, fa séguito la coscienza che
forse in fondo anche ‘la morte muore’ e che nella
sconfitta è possibile rinvenire valori e princìpi”.
Sergio Troisi [in Giornale di Sicilia, PA,
6.12.1986] sostiene: “E’ una pittura che procede per
allusioni, quella di Gigi Martorelli, […] dove lo
spostamento dal reale al visionario percorre così in
bilico il filo dell’intensificazione allucinatoria – e
mentalmente riepilogata - della visione”. Infine
Giovanni Bonanno [in Cooperazione 2000, anno IV,
n° 1, PA, gen. 1989] parla di “ iconismo di aniconie,
di immagini viste nella mente o intraviste in lembi di
paesaggi che l’immaginazione carica di valenze ‘altre’.
[…] La vibratilità segnica e cromatica di una pittura
mentale […] è segno di un lirismo che trova memoria in
Klee e Kandinskij e che si esplicita, all’interno della
strutturalità cubista, con una semantica concettuale e
barocca”.
TOGO
(Enzo Migneco -
Milano 1937) è nato nella capitale lombarda solo “per
avventura” (perché il padre vi si trasferì per un certo
periodo a causa del lavoro). Ma la sua formazione e la
sua esperienza di vita è tipicamente messinese (da
quando decise di dedicarsi all’arte prese un soprannome
per distinguersi dallo zio paterno, pittore
famosissimo). Consegue il diploma dell’Istituto
Superiore d’Arte di Palermo e fa la prima esposizione
proprio a Messina nel 1961, insieme con un amico
pittore. Si ritrasferisce definitivamente a Milano nel
1962. Abbinerà sempre alla pittura l’attività
d’insegnamento (da ultimo presso l’Associazione “Roberto
Boccafogli”, nell’àmbito di attività socializzanti). Non
si possono elencare le esposizioni, personali e
collettive, sia in Italia che all’estero (Polonia, New
York, Helsinki, Bruxelles, Germania).
Se è vero che gli inizi di Togo sono da ricercare nelle
esperienze del realismo (che egli, per così dire,
nutriva in casa), la sua pittura si contrassegna però
per un uso del colore di forte marca espressionistica. I
lavori esposti nel catalogo “Diarcon” a cura di Raffaele
De Grada, nel 1977, mostrano più un aspetto fauve,
ma poi l’impianto “geometrico” della forma si allenta in
quelli presentati nel 1981, all’Annunciata di Milano,
con presentazione di Paolo Volponi (né manca qualche
esempio che si richiama ai “vegetali” di Morlotti). Ma
le oscillazioni dialettiche, in Togo, rientrano nel suo
temperamento. In relazione a una mostra di grafica, dirà
Giorgio Seveso: “L’autobiografismo e l’autoanalisi sono
diventati ancora più incombenti, espliciti, decisivi.
Questo intenso viaggio all’interno del proprio volto
diviene il supporto per una riflessione in cui si
specchiano le tessere psicologiche di un presente fatto
di inaudite contraddizioni e di palpitanti speranze, di
coscienza e smarrimento, di contrastanti dati
esistenziali” [Catalogo, Spazio d’Arte, 1982]. E
sarà Paolo Bellini (1985) a individuare nel Volto
che dalle incisioni di Togo scruta “da fuori” la
composizione, più che una reminiscenza dei suoi stessi
autoritratti, un simbolo grafico della memoria
che rievoca, quella che assume il paesaggio raffigurato
in un silenzio atemporale. Intuizione ripresa e
sviluppata da Lucio Barbera (1991), che nel motivo del
Volto affiorante in un’atmosfera mitica ritiene
“sfondata” la superficie del foglio e creata una nuova
spazialità.
Anche Tommaso Trini afferma che Togo dipinge “da tempo i
luoghi sconosciuti di un paesaggio […] le cui apparenze
piene di nicchie e di penombra altro non sono che
l’altra faccia dell’interiorità, che lui scandaglia con
una foga introversa alimentata dal colore. […] La sua è
in verità una pittura della psiche”. E concludeva poi:
“Pittore dei lunari labirinti dell’animo, Togo è
ambrosiano mediterraneo. […] Nei suoi Paesaggi
mediterranei agiscono altrettanto magneticamente
l’espressionismo nordico e la penombra” [Catalogo,
Galleria Bonaparte, MI, 1992]. I lavori più recenti di
Togo, secondo Rossana Bossaglia, stanno sul confine fra
figurativo e astratto. Ma c’è sempre una “figuratività”
recuperata attraverso la memoria nelle sue campiture
cromatiche. D’altra parte dirà egli stesso: “Matisse e
Picasso sono gli artisti con cui dialogo
quotidianamente, entrambi mediterranei e solari” (1996).
ALFREDO SANTORO
(Messina 1939) insegna educazione artistica nella
città natale. Oltre alle esposizioni nelle varie
località isolane, c’è da registrare anche un’esibizione
a Kyoto nel
1989.
Franco Solmi [in Catalogo,
La Palazzata – Libreria dello Stretto, Messina, 1987/88]
afferma: “Non v’è dubbio che le suggestioni
dell’espressionismo tedesco […] hanno avuto notevole
importanza per lo sviluppo ultimo del lavoro di Alfredo
Santoro. Mi sembra comunque che la sua immagine […] sia
proprio la negazione dell’urlo espressivo e della
esagitazione formale caratteristica della pittura dei
nipotini antichi e moderni della Brücke. Mi
sembra che anche Lucio Barbera, che si è occupato […]
del lavoro di Alfredo Santoro rivelandone i punti di
riferimento e gli antecedenti in Schmidt-Rottluf, Heckel,
Müller, Nolde e riscontrandone le tangenze coi moderni
portatori del ‘selvaggismo’ tedesco, abbia voluto
sottolineare l’uscita del pittore siciliano dall’area di
questi condizionamenti […]. Se dovessi fare il nome di
un artista i cui modi linguistici e le cui soluzioni
formali non hanno alcun riflesso nel lavoro di Santoro
ma con il quale il pittore siciliano rivela indefinibili
consonanze e affinità, ebbene farei il nome del Klee più
magicamente simbolico. […]
Se qualche anno fa queste
testimonianze e confessioni liriche s’affidavano a
contesti pittorici vagamente tenebrosi, a cupe
ossessioni, alle simbologie dei trionfi della morte e
della distruzione atomica, al romanticismo tragico e
allucinato di Baudelaire, nelle ultime opere s’avverte
come il fiorire di una nuova felicità, di un canto
d’infanzia che ricorda assai più il sognante
primitivismo di Klee che non i ruvidi goticismi dei
neoespressionisti di
Germania”.
Caterina Giannetto afferma poi [in
Giardini mediterranei, estasi del colore, Magika
Ed., ME, maggio 2004 ]: “Egli giunge a una
composizione di colore e non di forme o di figure, è
un’emozione coloristica, una ‘gioia di dipingere’ di
chiara ascendenza matissiana, un’esaltazione di giochi
cromatici, nutrita spesso di numerosi particolari
decorativi. […] Sono stralci di una natura non
fotografica, ma filtrata, non realistica, ma visionaria.
[…] Santoro avverte in parte anche il richiamo di Paul
Klee, del quale non sposa l’astrattismo, ma ne mutua
quel ‘canto d’infanzia’ tanto presente in tutta la sua
ultima produzione. E del menzionato esponente del
Blaue Reiter l’artista siciliano apprezza
soprattutto il potere evocativo del ricordo in grado di
disgregare, riunire e combinare le immagini secondo
nessi alogici e asintattici. […] Spesso le sue opere […]
creano un collage: antico amore di Santoro,
mutuato non solo dai cubisti ma anche dallo studio di
Robert Rauschenberg, sua altra fonte artistica di
riferimento”.
TANO SANTORO
(Naso [ME] 1940) ha
avuto i primi rudimenti da un pittore locale, D’Ascola,
che gli permetteva d’affiancarlo en plein air.
Nell’àmbito del premio di pittura di Capo d’Orlando,
conobbe ed ebbe lezioni da Saro Mirabella e Armando
Pizzinato e soprattutto, per la grafica, da Tono
Zancanaro, che già Raffaele De Grada considerava come
“uno dei più straordinari inventori di forme che egli
avesse conosciuto” (1986). Dal 1962 si trasferisce a
Milano e farà un training pittorico e d’esperienza
presso la studio di Giuseppe Motti. Tiene la prima
personale a Piacenza nel 1967.
Sempre Raffaele De Grada afferma (1980) che in Tano
Santoro “l’assoluto della forma ha sempre avuto la
tenerezza che ci tiene lontano dallo schema. Eppure il
suo lavoro è di studio, di atelier. Non conosco un altro
artista più lontano dall’improvvisazione”. Dario
Micacchi sostiene (1991) che in lui “il segno spesso
appare come la traccia del meteorite che ha colpito o ha
strisciato violentemente la forma”. Giorgio Seveso
aggiunge (1994): “Non è tanto la rappresentazione
riconoscibile di figure o forme reali ad interessarlo,
quanto piuttosto la definizione, attraverso l’autonoma
fascinazione del dipingere, delle vicende amplissime e
sempre diverse del rapporto tra la nostra sensibilità e
i materiali emozionali della pittura”. A sua volta
Nicola Miceli (2003) parla nella sua pittura di
“presenze […] portatrici d’una eroica determinazione a
durare almeno quali tracce o graffiti stenografici della
corporeità, nel loro precario consistere; bisogna
cogliere e assimilare la febbricitante fisiologia di
queste tessiture ora rade ora fitte della materia, nel
tentativo di contenerne la deriva verso l’indeterminato
nulla o tutto del cosmo”.
Sotto un certo
aspetto, Santoro è un incisore anche nella pittura. Non
soltanto perché in essa tende alla monocromaticità, o
comunque su una sensazione di fondo di un certo colore
poi assembla gli accordi degli altri che più si confanno
sul piano del pathos e su quello dell’armonia
compositiva, ma perché la mano “agisce” alla stessa
maniera: preso e compreso da quell’emozione scatenante,
fissa per linee, tratti, per segni le sue addizioni (materiche
persino), come sulla lastra incide segmenti con
veemenza. E se i suoi filamenti e le sue sbavature, a
volte persino “macchie” lanciate in successione, possono
in parte richiamare la tecnica dei divisionisti, è la
pittura gestaltica dell’Informale e dell’Espressionismo
astratto ad avvicinarsi maggiormente. Il suo
espressionismo segnico non è più rivolto a “narrare”
fatti, ma a “esprimere” emozioni.
GIUSEPPE BURGIO
(Caltanissetta 1941)
ebbe il suo primo contatto con la figurazione a sette
anni, quando incontrò il “madonnaro” Matteo Presti. Fa
gli studi al Liceo Artistico di Palermo e poi
all’Accademia di Belle arti di Roma. Per lungo tempo fa
la spola fra la sua città e Roma, ma dal 1978 si
trasferisce a Reggio Emilia. Dopo un lungo periodo di
assenza dalle esposizioni, riprende l’attività nel 1990,
con una mostra organizzata dal Comune di nascita,
presentata da Vincenzo Consolo. Da lì in avanti esporrà
in varie città. Burgio ha sempre sottolineato, nella sua
pittura, una nozione di sicilianità rievocata dalla
memoria. Ma di quale sicilianità si tratta? Già Giorgio
Segato (2002) parlava di “enfatizzazione e
intensificazione” del dato naturale. Infatti i famosi
ulivi di Burgio, i suoi paesaggi e le sue nature morte,
non s’appartengono al rispecchiamento - effettuale,
avrebbe detto Leonardo Sciascia – di un dato reale
(anche quando la sua pittura viene accostata a Guttuso,
non c’è nulla del suo realismo, ma tutt’al più solo un
poco della vivacità fauve del suo colore), ma
sono immagini che riassumono le “caratteristiche
peculiari di un genere, di una specie”, sono cioè una
tipizzazione di una certa Sicilia.
Vagheggiamento e idealizzazione di una realtà scomparsa,
perduta per sempre, che “ritorna”, o almeno tenta,
attraverso il filtro memoriale, e in questo ritorno si
scorpora – può persino sembrare un paradosso – di ogni
peculiarità e particolarità dell’esistenza concreta. Si
tratta di una Sicilia pietrificata dalla sguardo di
Medusa, perché caricata di tratti ripetitivi e sempre
uguali a se stessi in quanto appunto solo mentali.
L’espressionismo cromatico di Burgio, che ha abbandonato
ogni sfumatura di tonalità a favore di accostamenti
sempre più timbrici e dissonanti, è proprio la
traduzione diretta di questa fissità astrattivamente
mentale. Dal tipo si passava così allo
stereotipo, che nasce “dall’uso rigido e
cristallizzato del quadro di riferimento” (U. Galimberti,
1991).
Per sfuggire alla variazione incontrollata, Burgio
passa, nella ultima fase della sua pittura, alla serie
dei rifiuti, cioé gli scarti e i residui delle
attività urbane e cittadine (anche gli
“sfasciacarrozze”, con i componenti meccanici e
metallici, accentuano vieppiù la lontananza
dall’ambiente naturale). Con un sottinteso polemico, la
sua denuncia ecologistica tende infatti a riaffermare
l’umano e a inverarlo in nuove costruzioni e rapporti
civili.
MIMMO GERMANA’
(Catania 1944 – Busto
Arsizio [VA] 1992) fu un autodidatta e fu lanciato da
Achille Bonito Oliva nell’àmbito della Transavanguardia,
negli anni Ottanta, insieme con Cucchi, Chia, Clemente,
Paladino, De Maria. Morì di Aids a soli quarantott’anni.
La sua è una pittura di stampo popolaresco, “ingenuo” (o
falsamente tale), con forti accentuazioni simboliche.
Tale carica simbolico-fantastica l’ha fatto definire “lo
Chagall italiano”.
Il suo espressionismo mediterraneo e il suo primitivismo
gli valsero comunque una partecipazione alla Biennale di
Venezia nel 1980. La sua tematica prevalente concerne
figure femminili dal volto ovale, spesso fluttuanti
nello spazio, e paesaggi dagli alberi stilizzati che
contrastano col fondo. Di lui dice Francesco Gallo,
forse il suo maggior critico: “Una fantasia abbagliante,
colorata, rapida, di gialli, di rossi, di blu, quasi
disarticolati dalla rapidità d’impatto, con cui vengono
sbattuti sulla tela […] a conferma del fatto che la sua
gestualità è parte integrante di una personalità, di un
habitus e non della mancanza di regole d’arte.
Quella di Germanà è, nonostante tutto, […] una sintassi
rigorosa della sua scelta espressionistica, della scelta
per la pittura d’impatto, che è la più adatta al suo
stile
onirico e trasognato, di una pittura […] in cui le
tonalità sono bandite e sembra debbano uscire le sagome
di Matisse e di Feininger, le pose femminili di Max
Pechstein, con il loro carico alcolico e sessuale, in
alcuni momenti anche la cromatica di Jawlensky, più che
quella dei suoi compagni di viaggio degli anni Ottanta,
Chia, Cucchi, Paladino, Clemente, De Maria”.
PIETRO
MANTILLA
(Messina 1949) si chiama all’anagrafe Mantineo e assunse
l’attuale nome d’arte quando, a ventitré anni, decise di
dedicarsi esclusivamente alla pittura, derivandolo dalla
mantellina che portava da bambino (ma nell’autoritratto
del 1982 usato come copertina del catalogo edito da
Magika nel 2005, in cui il volto si staglia contro il
fondo scuro, la mantellina lo fa assomigliare a un
caballero spagnolo del Seicento). In tale catalogo
Katia Giannetto lo descrive così: “Capelli ricci rosso
corvino, corporatura robusta, mani nodose”.
Sempre Katia Giannetto parla per la
sua pittura di “involgimento, processo opposto allo
svolgimento”, in quanto egli “liberamente ‘involge’,
cioé non esplicita, ma implicita un tema, un’idea sulla
tela”. E l’osservazione, più che una battuta, ha una sua
pregnanza in campo psicologico.”Mantilla - prosegue la
Giannetto - è attratto anche dai Preraffaelliti,
soprattutto da Dante Gabriel Rossetti, e questa ricerca
di semplicità e di spontaneità si coniuga […] con la
menzionata poetica naïf, lambendo sentieri cari a
Henry Rousseau il Doganiere. […] La lettura delle sue
immagini - tuttavia - provoca smarrimento, disagio,
dubbi, a volte scandalo e repulsione”. Sostiene poi la
Giannetto che “il disegno è l’emblema di tutta la vena
creativa di Mantilla, il quale adotta, come per i
quadri, una tecnica mista che si avvale non solo del
gessetto, ma anche del lapis, dei pastelli, della
tempera”. Così “la deformazione di oggetti, membra,
muscoli, corpi umani, si concretizza sulla tela in
composizioni difficili da leggere con parametri
meramente figurativi. […] Mantilla risente, più o meno
inconsciamente, di Pablo Picasso. […] Singolari affinità
di contenuti e di forme si rilevano anche fra Mantilla e
Francis Bacon, ambedue presentano la stessa visione
sofferta e angosciata dell’uomo, gli stessi corpi
deformati, quali frutti degenerati della società
contemporanea”.
Giorgio Seveso [in Catalogo,
Gall. Ciovasso, MI, giugno 2000] afferma che si tratta
di “un artista che, apparentemente, non ha in pittura
proprio nulla di siciliano. […] La sicilianità di
Mantilla si allarga, infatti, per il tramite di una
intensa sobrietà meditativa, a uno spleen più
universale, fatto di malinconia umana che non ha confini
di province o regioni. C’è in questi suoi quadri aspri e
ieratici dalle anatomie volutamente sgraziate e incerte,
carichi di pathos e di simboli come per l’ambientazione
di un tempio primitivo, una sorta di teatralità lirica,
di suggestiva ‘messa in scena’ che prende la sua
impronta profonda da un sentimento decisamente
drammatico dell’esistenza. Ne risulta il senso di un
estraniamento, di un distacco, di una distanza […] come
in una specie di crepuscolo metafisico”. Da parte sua
Teresa Pugliatti [in Mantilla (1974-1985), Gall.
Orientalesicula, ME, maggio 2007] sostiene che si ha in
Mantilla “una ricerca che scarnifica l’immagine fino ad
una apparente schematizzazione. Che è in fondo sintesi
mentale della realtà […]. Ma quando lo scavo sta per
diventare drammatico, Mantilla escogita un’idea giocosa
e pone, per esempio, accanto alla figura, o sulla figura
stessa, un particolare bizzarro, o un oggetto misterioso
che ne attenua la realtà, trasferendola in una
dimensione onirica e/o
simbolica”.
Che Mantilla sia un
malinconico-saturnino, che s’avvolge su se stesso in
deliri introspettivi, lo si può desumere anche dalla
tavolozza dei dipinti che vanno dal 1984 al 1999 (già
presentati alla Ciovasso di Milano): colori scuri,
tristi, soffocati e tendenti alla monocromaticità. Lo
strano è che anche in tale periodo la sua produzione
presentava opere dai colori più caldi e solari (almeno
in certi “particolari bizzarri”, come dice la Pugliatti),
mentre successivamente si aprirà a tonalità più accese e
a un impiego più accentuato dell’azzurro. La sua
introspezione – che quando si associa alla deformazione
figurale può retrocedere fino a richiamare un manierismo
da “talpa” alla Pontormo, come in Nuda appoggiata
– bene si sposa a volte con la preferenza di particolari
temi simbolistici, intendiamo quello storico di fine
Ottocento, come nel ciclo della Salomé, sul quale si è
espressa a chiare lettere Anna Maimone [in Catalogo,
Gall. Viscontea, Rho (MI), maggio 1998]: “Il fascino di
Salomé diventa quello della perversione. […] E’
un’occasione per rappresentare il contrasto tra orrido e
sublime, orrore ed eros. In Mantilla, come nei
decadenti, il sublime non c’è: restano l’eros e
l’orrore”.
MAURIZIO CITTI
(Catania 1959
– Ivi 2008) nasce nella città etnea un po’ per
caso, perché avrà la residenza fissa a Genova, dove
passerà l’infanzia e l’adolescenza. Tornerà a Catania in
età matura, dopo aver girovagato per l’Italia e
all’estero (Lione, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda),
partecipando a varie collettive. Ha avuto una formazione
da autodidatta, anche se frequenterà una scuola di
pittura.
Di lui dice Claudia Giraud: “Se la tecnica a olio
utilizzata nei suoi primi quadri ricalca la pratica
impressionista del dipingere en plain air e
ricorda la violenza postimpressionista di un Van Gogh,
per esempio nell’uso virtuosistico della spatola […],
col passare degli anni si precisa in una direzione nuova
e più intensa dal punto di vista del colore, in
coincidenza con un lungo soggiorno a Berlino, che lo
segna indelebilmente. […] Per la conoscenza anche solo
museale dei grandi maestri dell’espressionismo tedesco (Emil
Nolde su tutti), dai quali apprende la capacità di
liberare il colore da ogni funzione meramente
descrittiva, per fargli assumere invece un valore
espressivo autonomo, dal forte carattere emotivo. […] E’
radicata in lui una forte consapevolezza del senso di
responsabilità sociale della condizione di artista, ed è
per questo che la sua pittura ha assunto una figurazione
drammaticamente coloristica dei grandi temi di interesse
nazionale che hanno caratterizzato la politica italiana
degli ultimi trent’anni”.
Sergio
Spadaro
Milano, maggio 2009
|
|
|
|