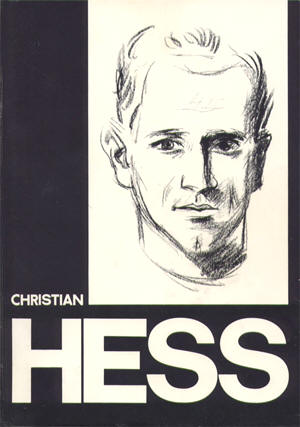 Vi
sono vite di artisti così poco indicative della loro
opera, da persuadere il critico a restare nell’area
estetica; quasi che fatti e travagli, se messi in
luce come per scommessa, costituiscano alla fine una
specie di indiscrezione, un apporto di “colore”
superfluo, per non dire dannoso. Certo ogni iter di
pittore, ogni sviluppo di un’arte che sia veramente
fisionomica, non ha bisogno di pezze d’appoggio; e,
senza dubbio, questo è il caso del pittore Christian
Hess; ma l’artista tedesco non appartiene alla
categoria di quei temperamenti che obbligano a
considerare la vita come una privacy, i suoi quadri
sono cosi pieni di testimonianze e vivono tali
esperienze, estetiche, di costume, di viaggi, di
climi, di caratteri, che quasi obbligano il critico
a ritrovarne la preistoria, a spiegarsi come e
perché l’artista abbia dipinto, guardando nello
specchio della sua vita.
Vi
sono vite di artisti così poco indicative della loro
opera, da persuadere il critico a restare nell’area
estetica; quasi che fatti e travagli, se messi in
luce come per scommessa, costituiscano alla fine una
specie di indiscrezione, un apporto di “colore”
superfluo, per non dire dannoso. Certo ogni iter di
pittore, ogni sviluppo di un’arte che sia veramente
fisionomica, non ha bisogno di pezze d’appoggio; e,
senza dubbio, questo è il caso del pittore Christian
Hess; ma l’artista tedesco non appartiene alla
categoria di quei temperamenti che obbligano a
considerare la vita come una privacy, i suoi quadri
sono cosi pieni di testimonianze e vivono tali
esperienze, estetiche, di costume, di viaggi, di
climi, di caratteri, che quasi obbligano il critico
a ritrovarne la preistoria, a spiegarsi come e
perché l’artista abbia dipinto, guardando nello
specchio della sua vita.
E a mano
a mano che, vicino alle opere compresenti, si
collocano momenti diversi della sua esistenza, la
personalità del pittore viene fuori a tutto tondo,
nella sua umanità e intelligenza, nel suo
anticonformismo, nel suo indomito spirito di
galantuomo democratico, di viaggiatore, di
fuggiasco, di innamorato, di amico dell’Italia e
della Sicilia, di fratello.
Dico anche di fratello perché per quasi
quarant’anni, in mezzo a mille peregrinazioni, egli
mantenne profondi legami con
la
sorella Emma, la sorella che - sposata ad un
italiano e scelta come sua seconda
patria
Messina - divenne, unica superstite della
famiglia, una specie di madre per l’artista, vissuta
da lontano e da vicino all’ombra del pittore; fu lei
che conservò e salvò durante l’ultima guerra buona
parte delle opere ad olio di Hess, le cartelle dei
disegni, la memoria, tappa per tappa dei viaggi e
dei successi di lui traducendo perfino in italiano
le lettere che le scrisse da ogni parte d’Europa
nella lingua natale; fu lei che ordinò via via gli
acquerelli, gli schizzi su fogli di ogni occasione e
povertà, che seppe ricostruire con l’amore operante
della testimonianza l’ideale archivio degli anni del
fratello.
 Quarantanove anni in tutto, la vita di Hess, fra due
guerre, periodo così drammatico e sconvolgente per
la storia non soltanto dell’artista ma dell’umanità,
che quasi non vi fu momento di vera pace nella
ricerca
instancabile di libertà. Potrei dire che la
vita e l’arte di Hess furono una continua coraggiosa
sfida della sua umanità contro due guerre e due
dittature. Nato a Bolzano nel 1895 e trasferito coi
genitori e le sorelle dopo dieci anni a Innsbruck,
il suo destino di artista era già segnato prima di
tutto nella mano artigiana: incisioni in legno,
linoleum, zinco, arte vetraria, ceramica, affresco,
furono i suoi primi cimenti, confortati fin da
allora da una cultura umanistica dai validi
strumenti, da un amore per l’immagine, felice e
perentorio.
Quarantanove anni in tutto, la vita di Hess, fra due
guerre, periodo così drammatico e sconvolgente per
la storia non soltanto dell’artista ma dell’umanità,
che quasi non vi fu momento di vera pace nella
ricerca
instancabile di libertà. Potrei dire che la
vita e l’arte di Hess furono una continua coraggiosa
sfida della sua umanità contro due guerre e due
dittature. Nato a Bolzano nel 1895 e trasferito coi
genitori e le sorelle dopo dieci anni a Innsbruck,
il suo destino di artista era già segnato prima di
tutto nella mano artigiana: incisioni in legno,
linoleum, zinco, arte vetraria, ceramica, affresco,
furono i suoi primi cimenti, confortati fin da
allora da una cultura umanistica dai validi
strumenti, da un amore per l’immagine, felice e
perentorio.
La prima guerra mondiale lo trova quasi
giovinetto nei reparti del Genio con elmo e chiodo,
sul fronte belga, a far luce, se così posso dire,
come riflettorista in quei tragici campi di
battaglia. La Somme, Verdun non furono per lui
titoli di giornale, ma lacrime e sangue. Viaggiatore
in arte, di giorno, attraverso le chiese
abbandonate, disegnatore di naja e di cartoline per
la pace nel 1917, finalmente reso libero dalla
sconfitta, cominciò nel 1918 il suo primo dopoguerra
di speranza a Monaco, centro culturale per le arti,
quasi come Parigi. Non che l’artista abbia sposato
la causa come si cambia un abito, di quelle ruggenti
avanguardie: “Die Brücke”, “Blaue Reiter”,
“Novembergruppe” restavano per lui delle ipotesi
stimolanti, ma piuttosto un mezzo, uno dei tanti
validi, e non un fine.
Per Hess, fin da allora, come sempre in tutta la
sua carriera, contava l’esperienza di vita, la
necessità di raccontare paesi e caratteri, come
prova del nove della pittura; non valevano per lui
le tendenze come moda, ma come specchio, se mai, di
situazioni morali e di costume, di quell’amore per
il prossimo, di quella più vasta cittadinanza che
s’era data in virtù dell’arte, fuori dei confini di
Versailles. E benché abbia sempre operato dinnanzi
alle sue tele come un consumato professionista,
sapendo ad ogni tappa che cosa volesse e in quali
limiti, di tradizione o di avanguardia, dovesse
contenersi (tutta l’arte di Hess può definirsi in
una marcia di trasferimento da una figurazione post
impressionista ed espressionista a un gusto di
avanguardia temperato, con qualche punta di
astrattismo più programmatico) egli non disdegnò un
tipo di lavoro, congeniale alla sua vocazione, ma di
stampo più manuale - del resto, stimolante non meno
di quello della ricognizione avanguardistica - di
copista, su commissione, dai maestri della scuola
fiamminga, dal Veronese, da Tiziano, da Velasquez;
sia perché i tempi duri non gli consentivano di
espletare i suoi compiti di artista con la
maiuscola, sia perché - come accennavo - egli intese
la sua arte anche come mestiere, nella globalità
popolare e dotta, artigiana e sperimentale.
Se aveva peregrinato in diversi fronti, in tempo
di pace cominciò dunque altri viaggi, in Svezia, in
Danimarca, in Austria e già nel 1925 in Italia,
naturalmente a Firenze e poi a Messina, per una
estate, dalla sorella Emma. Questa meta al Sud, con
la Sicilia come regina della natura, mecca della
luce, genesi quasi biblica, del colore, sarà una
costante dell’artista e quasi una meta. A Messina
lavorò fervidamente, a Messina scoperse quella
dimensione mediterranea che forse per altri
“stranieri” sarebbe stata una occasione di pittorico
turismo, ma che per Hess fu una straordinaria
palestra di umanità, gloria e miseria, amore per le
classi diseredate, rispetto della vita. E ci venne
anche in due momenti diversi portando ogni volta una
compagna, nel 1926 Maria, vedova giovane di un alto
ufficiale imperiale, e nel 1934 Cecilia Faesy,
figlia di un banchiere svizzero, che sposò a
Messina. Si stabilirono in una casetta nella riviera
di Mili, ma dopo qualche mese la moglie ripartì.
Non è qui necessario seguire anno per anno le
peregrinazioni dell’artista, i suoi arrivi e le sue
partenze per Monaco, l’altro punto estremo della sua
spola. Ma è il caso di dire che, mentre l’artista
portava in Sicilia la sua esperienza di figuratore
educato dall’Europa, ricambiava i doni di questa
cultura riportando a Monaco e in Germania,
condensato nei suoi quadri eseguiti nelle brume,
tutto il sole dell’isola. Per vivere continuò a
dipingere su ordinazione degli americani venuti a
Monaco per il famoso carnevale, ma affrescò a
Wismar, tra le bottiglie del vino del Reno non meno
generoso del Corvo e del Marsala, la grande cantina
di una villa coi ricordi della Sicilia.
Il destino delle sue opere, se ne togliamo
quelle che conservò la sorella fu incredibilmente
negativo: molte andarono distrutte o perdute nei
trasferimenti, altre presero in Germania e
all’estero la via di collezioni non più reperibili,
dopo lunghe giacenze in depositi o presso amici e
conoscenti che se ne disfecero, altre bruciate (“un
anno di lavoro”) nell’incendio al Glaspalast di
Monaco di tutta la mostra dei giovani artisti della
Juryfreien, il movimento di punta dei “fuori giuria”
del quale il pittore fu animatore. Una storia,
quella umana di Hess, che potrebbe interessare anche
un narratore o un regista. Lo vediamo a Oeynhausen
ad affrescare in quelle terme tra i vapori le pareti
con una tecnica speciale a cera, a far conferenze
sull’affresco - meta e cavallo di battaglia di tutti
i figuratori degli anni Trenta, da quelli del
Novecento ai Messicani - con animo archeologico a
Selinunte con animo unitario a Palermo; tedesco
democratico a Berlino sotto i primi furori
“incredibili” dell’hitlerismo, pacifista a Lucerna,
a perpetuare la tradizione dell’esule, con la figlia
del banchiere senza un soldo, a intagliare pupazzi
nel legno alla maniera sopraffina dei carrari di
Bagheria e a far scenari per i teatri di marionette,
mentre gli amici restati in patria gli scrivevano
della Germania “cose mostruose”. Lo ritroviamo a
Roma negli anni della Conciliazione, venuto al Sud
cogli abiti d’estate in un inverno inclemente, a
ghiacciarsi nei Musei e per le strade che
“formicolavano di preti e di gendarmi”, tanto che si
ammala, viene curato dai compatrioti e visitato da
Karl Hofer.
E’ tanta la nostalgia del lavoro, che appena
convalescente ritorna a Monaco. E, tipico specchio
di anticonformismo, quasi di ribellione, nel 1931,
alla massima apoteosi delle “camicie brune” egli
risponde col massimo della sua sperimentazione
astratta, forse l’unica proposta di libertà che
poteva concedersi un artista in quella tragedia.
Coi pochi quadri rispeditigli dagli amici dopo
il soggiorno di Lucerna, la fuga in Sicilia, la
separazione da Cecilia, restò a Messina quasi tre
anni, dal 1935 al 1938, in una situazione economica
e psicologica di gravissima crisi, tanto che per due
volte tentò di togliersi la vita. Non è a dire che
l’Italia fosse anche per lui un Eden: tolta la
natura, l’archeologia, la potente capacità di
sopravvivenza delle classi popolari, l’aria del
regime, avvertita soprattutto nella frequentazione
della media borghesia, lo avvelenava anche da noi; e
più forte avvertiva il divario di una cultura in
quegli anni depressa nel campo delle arti figurative
(i migliori artisti nati nell’isola erano emigrati
al Nord, da Guttuso a Consagra, da Mazzullo a
Migneco da Franchina a tanti altri), ancorata a una
tradizione, nella migliore delle ipotesi,
novecentesca e la sua esperienza quasi ventennale,
aperta alle tendenze di avanguardia.
Fino a che l’artista veniva in Italia dalla
piattaforma europea, l’Italia gli appariva dunque
come una inesauribile miniera di tesori d’arte, di
suggestioni nella natura; ma ora, tagliato fuori dal
suo Paese, inagibile, egli soffriva tutta la
solitudine di un vero abbandono, né la difficoltà
della lingua poteva facilitare l’incontro con quei
“solitari nostrani”, che anche allora non mancavano
- anzi - ma che non conobbe.
Tornato in Svizzera, trascorse un periodo assai
gramo nel continuo timore di una espulsione come
cittadino tedesco, costretto ad esporre e a vendere
i suoi quadri non firmati. Ma la Germania lo
calamitava sempre, la nostalgia della “sua gente”
era per lui fortissima, tanto più nel quadro di
quella mortificazione generale. E nei buoni ed
onesti come fu lui, era anche una specie di speranza
impossibile, tuttavia accarezzata, di riuscire a
vivere anche in mezzo ai nazisti, salvando la
libertà: “I segni che in Germania si prepara
qualcosa, sono evidenti e i miei amici mi scrivono
cose mostruose. Voglio andarli a trovare entro
l’anno prossimo per convincermi se vi potrà essere
ancora libertà per il nostro lavoro o se tutto è
ormai perduto. In questo caso sarà indifferente dove
mi metteranno in carcere...”.
Ed eccolo nel 1939 di nuovo a Monaco. Un deserto
la vita artistica, e lui troppo legato a questa per
assumere, militandone fuori, un ruolo antinazista.
Dalla Svizzera era partito sotto l’incubo
dell’espulsione, a Monaco viveva nel terrore di un
richiamo alle armi, per una guerra ben più
odiata di quella del ‘15-18. Segnalato dalla
polizia a Oberwössen, fu dall’oggi al domani
incorporato nel servizio civile e assegnato alle
Poste. Cinque anni ancora di tribolazioni, la grave
malattia ai polmoni, il sanatorio, la precaria
“convalescenza” nella miseria dopo la chiusura della
fabbrica di tessuti per la quale preparava i disegni
a trecento marchi al mese, l’ultimo suo lavoro a
Zirl sulI’Inn dove affresca le sale del palazzo
comunale e “l’unica (sua) gioia - scrisse
nell’ultima lettera alla sorella - la lettura dei
poeti greci e un quarto di vino rosso”.
Nel novembre del 1944 mentre ancora inseguiva la
sua introvabile pace, la guerra lo raggiunse e lo
stroncò. Respirava ancora quando fu disseppellito
dalle macerie di quella incursione aerea. Il 26
dello stesse mese morì nell’ospedale di Schwaz,
presso Innsbruck.
“Che
nessuno si fidi di darmi in mano un fucile, tranne
che contro Hitler
- aveva scritto alla sorella - Certamente lui
sarà ucciso prima che noi si debba imbracciare le
armi e compiere ciò che lui e i suoi fanno
adesso...”.
E se gli eventi non furono questi, gli riuscì
almeno di marciare fino in fondo verso la morte come
un soldato della pace.
Non che l’artista abbia avuto in morte tutti gli
onori che meritava il suo talento, si può dire,
anzi, che per la prima volta dal lontano 1944,
parenti, collezionisti, estimatori, studiosi, hanno
sentito la necessità di riproporre in una quanto più
ampia e illuminante ricostruzione, tutta l’opera del
pittore tedesco, con una serie di iniziative che ne
esaltino qualità e prestigio. Ma è doveroso e
confortante ricordare che, nei limiti di quei tempi
stremati seguiti alla guerra, la carità di patria
non mancò a Christian Hess, se già nel 1948
all’Exportschau di Monaco diverse tele dell’artista
furono esposte insieme a quelle di Max Beckmann e di
Willi Baumeister, due maestri tedeschi, insieme a
tanti altri perseguitati dal nazismo, che tennero
alta la bandiera dell’arte di avanguardia odiando la
dittatura.
 Vorrei
cominciare la lettura delle opere di Hess con
un’opera del 1922,
“Baronessa con veletta”,
perché l’allora ventisettenne pittore mostra con
questo quadro un biglietto da visita, per dir così,
stampato nei caratteri cittadini della Monaco del
dopoguerra, la più “ruggente” e informata, la più
spregiudicata; e anche se l’artista arriva a
bloccare in un ritratto parlante il clima delle
esperienze dopo i decenni della “scuola di Parigi”
in virtù del suo temperamento, più di intuizione che
di programma, l’opera resta pur sempre un punto
fermo della sua qualità e della sua cultura: una
statura, insomma, dalla quale egli potrà concedersi
esperienze assai diverse e anche lontane fra loro,
perfino ritorni nell’area impressionista e
espressionista tout court, ma mai tornare indietro o
ripiegare su posizioni di comodo. Dunque, dentro un
fondo perla azzurro, serico, l’aristocratica dai
capelli rossi debellati, dagli occhi a palla che
guardano fra noia e ostilità, attraverso le paglie
cenere della mezza veletta, celata d’aria
all’indiscreto per la sua indiscrezione
costituzionale, la pelle bianca su cui rossetto e
bistro fanno un altro incarnato - non si strucca
neppure per implorare, se mai l’ha fatto - le
braccia conserte sul freddo del vestito di raso,
semplice come quello di una spartana da salotto, è
personaggio così autorevole e preciso, da vivere di
vita propria dopo tant’anni di polvere, fra donne di
eguale grinta e rispetto di questo 1974, inter
pares.
Vorrei
cominciare la lettura delle opere di Hess con
un’opera del 1922,
“Baronessa con veletta”,
perché l’allora ventisettenne pittore mostra con
questo quadro un biglietto da visita, per dir così,
stampato nei caratteri cittadini della Monaco del
dopoguerra, la più “ruggente” e informata, la più
spregiudicata; e anche se l’artista arriva a
bloccare in un ritratto parlante il clima delle
esperienze dopo i decenni della “scuola di Parigi”
in virtù del suo temperamento, più di intuizione che
di programma, l’opera resta pur sempre un punto
fermo della sua qualità e della sua cultura: una
statura, insomma, dalla quale egli potrà concedersi
esperienze assai diverse e anche lontane fra loro,
perfino ritorni nell’area impressionista e
espressionista tout court, ma mai tornare indietro o
ripiegare su posizioni di comodo. Dunque, dentro un
fondo perla azzurro, serico, l’aristocratica dai
capelli rossi debellati, dagli occhi a palla che
guardano fra noia e ostilità, attraverso le paglie
cenere della mezza veletta, celata d’aria
all’indiscreto per la sua indiscrezione
costituzionale, la pelle bianca su cui rossetto e
bistro fanno un altro incarnato - non si strucca
neppure per implorare, se mai l’ha fatto - le
braccia conserte sul freddo del vestito di raso,
semplice come quello di una spartana da salotto, è
personaggio così autorevole e preciso, da vivere di
vita propria dopo tant’anni di polvere, fra donne di
eguale grinta e rispetto di questo 1974, inter
pares.
Un altro dipinto a mio avviso importante, anche
se di impegno minore e poco più di un bozzetto, che
merita di essere illustrato al principio di questa
analisi, è
“Bagnanti sul lago”
(1924) di tutt’altra grana, dove l’impeto
espressionista non riesce a depositarsi; ma piace la
veemenza del segno tutto di pennello, il ritmo
serrato della composizione, quel di più di
pittoresco che dalla scena romantica di un
Delacroix, diventa immagine di natura, uno dei punti
di oscillazione dell’arte di Hess.
Perché è il caso di precisare subito che il
pittore, per tutto il suo arco operativo, pur
mantenendo una riconoscibile costante in chiave
realistico espressionista, la sua bella tensione
plastica per una sintesi della realtà sensibile,
sperimenterà, ora in chiave di assaggio o solfeggio
per una prova della luce e della cromia, ora in
chiave di più approfondita progettazione nel segno e
nel rigore volumetrico, altri “gusti”, passati e
coevi: dall’impressionismo, risentito, per
pennellata, cadenze e tavolozza nell’espressionismo
- ma eseguirà anche opere legate allo schema post
impressionista naturalista, per es. del tipo del
nostro Arturo Tosi -, ai modi abbastanza simili a
quelli del Novecento italiano, cosi come la
saturazione avanguardistica li aveva collocati
dentro i ripensamenti del “ritorno all’ordine” e
contemporaneamente (sembra una contraddizione, ma
non lo è, per un artista che viene da lontano) ai
modi degli astrattisti tedeschi e italiani a cavallo
degli anni Trenta, Baumeister prima di tutto.
Del resto, se in diversi momenti della sua ricca
e varia carriera il pittore avvertì la lezione
dell’arte italiana, assai scarsa in quegli anni di
lieviti impressionisti, fu per lui piuttosto un
incontro con la solarità del nostro paesaggio, in un
impeto tutto tedesco, espressionista al fondo. Si
guardi a questo proposito, della sua prima stagione
italiana, meridionale e siciliana, nel quadro dell’
“Asinello e fichi d’india”,
come è cupa e obnubilata l’atmosfera, come si
assommano per macchie risentite le pennellate, a
fare una tessitura irta e smagliata, come l’animale
è piantato sghembo sulla sua ombra violetta, come
irrompano i fichi d’india, scheggioni di
luce-colore, fino a quel mulinello del cielo, che
pare l’inizio di un cataclisma.
Per quanto poi riguarda la sua affinità col
Novecento italiano, che dovette pur apprezzare nei
suoi valori e maestri maggiori, più che l’aspetto
mitico e classicheggiante, celebrativo e
trionfalistico del “grande passato”
accarezzato dalle medie borghesie uscite fuori
“deluse” dalla prima guerra mondiale, Hess coglie
del “ritorno all’ordine” quello che Lionello Venturi
chiamò il “ritorno alla natura” e dell’Italia e
della Sicilia gli aspetti umani, nobilitando dentro
un rigore plastico ben lontano da artifici
accademici e manieristici, tipi e folklore, volti di
piazze italiane e di regioni:
“Campagna di Firenze”,
“Carretti e
ulivi a Messina”,
“Sotto i fichi d’india”,
“Bracciano”,
“I templi di Agrigento”,
“Forte Gonzaga a Messina”
- di cui e’ riconoscibile, oggi, soltanto il
cucuzzolo turrito del monte - “Piazza Navona”, nel
gusto incredibilmente vicino a quello del Virgilio
Guidi prima della sua partenza per Venezia
intorno al 1925, sono tutte presenze italiane, tanto
libere, quanto responsabili: perché dovunque
l’artista arrivasse in quella sua vita di pittura,
o, se si preferisce, in quella pittura tutta nella
vita, sapeva avvalersi della natura come di un
baricentro, la sua visione era sempre “all’interno”
del luogo, non turistica, non evasiva.
E’pure del 1925
“Donna che riposa”.
Mi pare che in quest’opera cosi robustamente
dipinta, della dormiente che racchiude le braccia al
petto per una costrizione necessitata dal rettangolo
della tela, ma altrettanto naturale nella posa, come
sono appunto le pose che esprimono un preciso stato
d’animo e quasi una condizione della vita, il
bronzeo tono della luce pomeridiana, la felicità dei
pochi elementi ambientali, quel riquadro di azzurro
alla brava che richiama come in un “emblema di mare”
la presenza del Sud, continui la costante del
pittore, collocandosi sempre più autorevolmente nel
quadro dei valori umanistici conservati dopo lo
scoppio delle avanguardie, senza alcuna recitazione
novecentesca e senza alcuna indulgenza
naturalistica.
E’ bene sottolineare a questo punto che, se
parecchie opere di Hess, specie disegni e ritratti,
sono affidati ad una vena di energica figurazione
diretta, al temperamento del disegnatore, fin quasi
a configurare nell’arte del pittore una specie di
altra faccia della luna naturalistica, sempre il
motivo ad olio è rimeditato con la dovuta
elaborazione cromatica, diventa astratto, acquista
le inconfondibili e gravi cadenze di sintesi del
Maestro. Del resto, da un esame attento di tutta
l’opera grafica e minore di Hess, si ricava, anche
qui, che i motivi e i modi realistici non sono fini
a sé stessi, ma costituiscono, il più delle volte,
una necessaria preistoria all’iter maiuscolo dei
suoi quadri.
Se certo non si può parlare nell’arte di Hess di
una continua mediazione di Monaco con Messina, si
può affermare che una cultura midleuropea e una
cul–tura mediterranea abbiano trovato nell’artista
parecchi punti di armonia. E fin dal 1928 il clima
di Monaco, al quale si ispirò pure il De Chirico
metafisico, si trasferì nella mediterraneità dei
suoi soggetti e paesaggi. Come pure accadde il
contrario e cioè che il richiamo luministico del
paesaggio siciliano abbia preso la mano al pittore
(ma con un abbandono nella carne della pittura, che
alla fine si traduce in una sorta di rinsanguamento)
in opere del tipo di
“Uliveto con casa”,
“Via Palmara”,
“Uliveto con donne”.
Ma si guardi del 1927 il “Nettuno”, uno dei quadri
inconfondibili di Hess quale viaggiatore del sole,
quale artista pensante con la mente monacense
dinnanzi a una “materia” messinese: quel Dio
dell’acqua su basamento che sporge il braccio come
un Cesare, più nudo che statua, fra i due
rimorchiatori listati di rosso e di nero nella gran
luce azzurra del porto e il popolo ai suoi piedi,
mitologico e no, una assemblea da fontana che è
insieme inno alla presenza muliebre, quel Nettuno
che in tanti disegni e schizzi l’artista fa sbucare
dietro balconi di case (alla maniera delle
gigantesse di Picasso del periodo “surrealista” in
bianco e azzurro o nel paterno grottesco dei barbuti
vecchiardi di Savinio tra favola e archeologia) sono
ingredienti di gusto aristocratico, ma calati in un
sentimento che tiene conto del lavoro e della
fatica, che ripresenta il paesaggio siciliano come
l’habitat dell’uomo laborioso e organizzato.
Invece, sempre del 1927 col quadro
“Caprone sotto i fichi d’india” l’artista si trova,
mente e sensi, tutto o quasi, “da noi”: il caprone
preistorico nella calura riverberata dalle rocce,
quell’albero dalle pale possenti, plasticate come
per una presenza tridimensionale, quella sintesi che
scatta da una visione che impressionista non è più,
che cerca un’altra collocazione e la trova nei suoi
ritmi di rosa e verde, di primi piani a stacco della
profonda valletta. Come pure si tratta di Sicilia
nel quadro appunto dal titolo
“Balcone in Sicilia”, eseguito un anno dopo; ma
qui - si ripetono le oscillazioni culturali e di
ispirazione dell’artista - prevale lo schema
astratto nella “rarefazione” dei pretesti della
natura morta in primo piano nell’astrazione di una
realtà sensibile, nell’equilibrio fra schema mentale
e natura. E della stessa sintesi è il puro e intenso
acquerello “Firenze 1928” con quel sole di mite
incandescenza sul controluce smeraldo della collina.
E che dire delle “punte avanguardistiche” quasi alle
soglie della metafisica (ma qui veramente l’artista
non passa attraverso De Chirico, se mai entrambi si
rifanno a un gusto simbolico nella natura, di
Böcklin) del bellissimo dipinto “Bracciano” col
ponte di ferro che semi-nasconde il castello, il
quale a sua volta appare con la facciata dalle
finestre cieche nei neri dechirichiani, rosato,
dentro l’alone del cielo? Quadro rigoroso nella
“macchina” compositiva, ritmata dalle liste del
ponte in una chiave grafica, intrise di verde nei
tiranti che bucano la prospettiva, una delle opere
che si ricordano anche al di fuori e al di sopra
dell’iter di Hess.
Un gruppo di opere, tutte del 1928,
stanno nel mezzo, nei punti medi delle sue vane
esperienze, prevalendo, anche per l’imperativo dei
temi, un gusto realistico. Mi riferisco a “Ragazza
che dorme su cuscino giallo”, che presenta la
medesima struttura “anti-impressionistica” del
quadro del caprone, il medesimo piglio vigoroso a
bloccare l’insieme, quella dolcezza calata nella
forza, quel luminismo castigato nei chiaroscuri, che
però si risolvono in volumi niente affatto
“romantici”. Del ‘28 è anche il
“Suonatore biondo”, opera che partecipò a un
concorso sul tema “Musica nella pittura”, nelle due
versioni che presero il titolo di “Prova al concerto
1 e 2”, dove, ovviamente, più che la musica, è
personaggio il giovane suonatore di oboe, dagli
occhi bruni e teneri, il pelo sulle guance non
rasato, la sciarpa di seta a coprir la maglia e
quelle due rughe di impennata povertà sulla fronte;
a fare il present’arm col suo strumento. Hess eseguì
parecchi ritratti anche su commissione, ad olio e a
tutto tondo, cimentandosi anche nella scultura, che
però gli servì soltanto come palestra di
ricognizione plastica e che non considerò mai come
obbiettivo finale di espressione.
Taluni ritratti però sono bellissimi,
come il primo dipinto qui illustrato, e come questo
di famiglia “La signora M. N. con i figli” (1928),
una delle più belle madri-leonesse che io ricordi
dei moderni, in quel gusto umanistico e “astratto”,
da Cezanne, che ritrova in maniera tanto consapevole
la chiave populista dei Picasso rosa e bleu, specie
a guardare la testa del bambino sulla destra del
quadro. Ritratto di famiglia, nel medesimo clima,
può essere considerato anche il dipinto “Coppia in
costume da bagno” (1930) dove il Picasso del periodo
rosa sembra prender carne nella naturalezza di
quell’incontro dei giovani, quasi coniugale, nella
sintesi cristallina della bionda, nella croccanza
dello smalto che si stratifica come se un polline si
condensasse, nella luce insolitamente mattinale -
che pur svaria in curiose nicchie di fondi, dietro
le teste dei personaggi - in quello spazio araldico
entro il quale sono collocate le figure.
Vitalità fra “attimo fuggente” e sintesi
plastica è anche nel ritratto della “Donna col
cappello nero” (1930), psicologicamente resa
attraverso l’immensificazione degli occhi, il
collocamento del busto, molto in basso rispetto alla
campitura gialla del fondo, con quel lutto mentale,
quel pensiero fisso, reso come rituale dal cappello
a cimiero. Ritratti, come si vede, ben fuori della
convenzione e dell’occasione, ma incontri con
persone da capire ed amare, specchio di anime nei
segni e nei colori. Come anche in “Donna in celeste”
(1931) che pare una tempera, tanto la sintesi
impoverisce volutamente l’iride e spegne le gamme
splendenti. Il viso è scavato quasi in un bianco e
nero, e l’antigrazioso della faccia, dura,
disadorna, è riscattato dalla naturalezza, direi
dalla umanità di questa presenza, che ride seria.
Dicevo che l’aria di Monaco rende
pungenti, notazioni e temi di natura già negli anni
Trenta e vi sono opere di questo momento ancora più
esplicite nel gusto delle avanguardie di allora, che
lo attestano, come per esempio “Case rosso-nero” uno
schema di paesaggio non del tutto trovato
nell’astrazione, ma con belle cadenze di geometrie
luministiche, a zebrare e scheggiare di bianco il
fondo di persa ceralacca. (Una tavolozza che sarebbe
piaciuta al Prampolini di queghi anni). Dal 1931 al
1935 i modi, chiamiamoli cosi, realistici e quelli
astratti, si alternano nella pittura di Hess con
tale tensione, da costituire quasi due anime in una,
due momenti che si caricano a vicenda. Si veda,
della oscillazione astratta, il felicissimo dipinto
“Melanzane e
peperoni” (1933) ovvero la “Natura morta con la
gazzetta”, risolta con l’autorità di chi ha saputo
ridurre a sintesi la impressione sensibile e
capovolgere verticalmente il piano, come per una
contemplazione senza più un centro prospettico; “I
piccioni sulla terrazza”, deliziosa fiaba tra
balaustrate di marmo, cupole e nubi, queste ultime
ritagliate nello spazio come forme “decorative”,
eppure cosi viventi nel cielo tra ardesia e azzurro,
con quelle tre soavi colombe fatte di luce,
composizione perfettamente scandita e di preciso
valore poetico; e, per proseguire in questo
inventario di opere in prevalenza astratte, quel
piccolo capolavoro delle “Aguglie sulla fruttiera”
(1933), con tagli così asciutti di cromia, tra
cubismo e chiaroscuro, tra pittura all’aperto e
affresco nel tetro lume degli interni, che pare
cugina della tavolozza degli “omini” di Ottone
Rosai, e proprio negli anni Trenta.
E ancora: la “Natura morta verticale” dei
pesci rossi e dei fichi d’india, modulata nella
prospettiva ribaltata che s’è vista a proposito di
“Melanzane e peperoni”, la “Natura morta della
quartara”, più un assaggio, nella sintesi pur
felice, morbida nelle gamme verdi e cotogna (1933).
E se passiamo alla figura, nella quale, come ho
indicato illustrando opere eseguite in vane date,
l’abbandono al vero ha per Hess un ruolo importante,
non dobbiamo dimenticarci che uno dei personaggi
dipinti dall’artista, piü vivi e oniginali, è
l’astrattissimo “Giocatore di scacchi” (1931) col
braccio appoggiato alla scacchiera come su una
mensola della foto ricordo, gli occhi di carbone, il
chiaroscuro della faccia così metallico da creargli
una sorta di pelugine, una muffa d’ombra, il
magnifico riquadro del biliardo, l’ambientazione
quasi funeraria del fondo sul rosso baldacchino, una
delle massime punte di liberazione e di invenzione
del Maestro. Ma nel discorso più legato all’Italia e
al suo folklore, sono pezzi tipici di Hess, in
primis, ”L’indovino” (1933), motivo assai
accarezzato e riproposto dall’artista in numerosi
disegni, di insieme e di particolari. In questo
quadro fondamentale si assiste a una specie di
inventario dei motivi siciliani, che però si
armonizzano in una scena-composizione; e non
perdendo per questo la loro vitalità quasi
simbolica, nulla concedono ad una descrizione di
comodo: il primo piano del carretto siciliano con i
suoi colori arancio, bleu e rosso, il cesto delle
melanzane bianche, sormontato dalla testa del
pescatore con la corta pipa di gesso, inclita e
cose, su cui svetta (come svetta il Nettuno sulle
matrone di fontana nel porto di Messina) il
personaggio della fantasia popolare, il portatore di
illusorio futuro, con la coppola contadina, la
tromba e la gabbietta, su cui prillano le
bandierine, non esclusa quella italiana, non a caso,
e per pura incidenza formale, già... repubblicana. E
quale attonita curiosità, quale rispetto della gente
per quel messaggero della fortuna.
Immedesimazione nel popolo siciliano, quella di
Hess, per dare la necessaria compagnia alla sua
solitudine di viaggiatore della pace. E ci si mise
anche lui a vogare, in barca e dentro il quadro, con
il baschetto rosso, la grinta che par sorridere ai
nipoti, l’impugnatura ciclopica del remo per fare la
storia di Scilla e Cariddi, lui del Nord, come a
dire che non c’è altra patria che quella del sole,
che il lavoro e la fiducia nella vita non hanno
confini. Mi riferisco al quadro dal titolo
“Autoritratto sulla barca” (1933).
Anche l’olio “Ladro e carabiniere” (1934)
è quadro tipico dell’Hess italiano il picciotto
catturato, non si sa bene se faccia semplicemente il
modello per portar colombe, o mostri il corpo del
reato. E senza voler calcare su questo simbolo,
viene spontaneo alla mente questo "furto di pace”,
nella colomba. Fatto sta che il carabiniere in alta
uniforme, forse per conferire prestigio all’ingrato
compito della giustizia, coi baffoni marziali per
aiutare lo sgomento, la bocca atteggiata a un mezzo
sorriso per farsi perdonare, si presenta quasi come
un amico, un cugino dell’altro in borghese. Qui Hess
ha colto in una chiave tutta insulare, che però non
gli fu mai estranea, anzi, in altre drammatiche
circostanze nel suo Paese, l’antica protesta del
diseredato contro “la legge” ed ha atteggiato i due
a una recita che si ripete ormai da secoli, la
miseria che si fa colpa e perciò diventa un castigo,
anche da parte della legge. E quali smaglianti
colori, a dire questa parabola, quale naturalezza di
scena, vista e presa, dopo tanti disegni ed
acquerelli, fortunatamente conservati.
Dicevo che v’è un gruppo di opere di Hess
che si avvicina al gusto del Novecento, sia per una
accentuazione veristico accademica, sia per una
certa “solennità” di positure. Nei dipinti più veri,
collocherei “La prova delle modelle” (1931) e “Nuda
in piedi che si pettina” (1932), in quelli di un
certo rigore jeratico, “Riposo dei muratori” (1929),
“Bagnante col turbante” e “Bagni di sole” (1931).
Tra i motivi più validi dell’artista, sono, come ho
già detto, quelli delle figure femminili, di
vigorosa sintesi, “Nel camerino” (1932),
“Due modelle”, “Tre modelle” (1933) e tra i nudi,
quella perla di bianco e rosa, distesa sul letto di
tulle trasparente, incapsulata e come riscattata
dalla sua delizia, in un fondo di mare e vele
metallico, che redime la straordinaria morbidezza
del corpo “Suggestione” (1934) e anche “Nudo di
spalle” (1931) di notevole vigore plastico, in una
nostalgia dell’ultimo Renoir.
Ma voglio finire, come ho cominciato, con
un altro capolavoro dell’arte di Hess, di soggetto
femminile e anche questo un ritratto, che mantiene
fede alle premesse già maiuscole dell’antico dipinto
della “Baronessa”, la “Modella nell'atelier” (1932):
a cominciare dall’originale taglio sghembo del viso,
rispetto al rettangolo del quadro, la frangetta, la
faccia a mandorla, il gran mento sufficiente, la
pelliccia tarlata del volpino sulle spalle, ma cosi
“irosa” nella cromia e nello smalto, che sembra
stringersi attorno al collo l’animale ancor vivo.
Non mi
rimane che aggiungere, a conclusione di questo
ritratto di artista, che di rado mi è accaduto di
scrivere su una personalità di pittore, a me del
tutto sconosciuta e come risorta dal nulla, con
l’entusiasmo e la convinzione di una antica
amicizia; mi pareva di averlo avuto sempre presente,
che mi dettasse lui stesso, dai quadri,
naturalmente, le parole da dire. Sono tanti anni
ormai che faccio il mestiere di critico e credo che
sia difficile sbagliarmi, quando una voce mi chiama
a questo modo: vuol dire che l’artista c’è, con il
suo dolce furore di vita, la sua gloria.
Marcello Venturoli